 La nascita del Macerata Opera Festival 2012 è stata parecchio travagliata: esaurito il rapporto con Pier Luigi Pizzi, precedente direttore artistico (la cui uscita di scena, a onor del vero, poteva essere gestita in maniera alquanto migliore di come non sia avvenuto) lo Sferisterio è rimasto fino a gennaio 2012 senza una guida e, ovviamente, senza una stagione. Solo ai primi di gennaio si è ufficializzata la nuova direzione artistica di Francesco Micheli, il cui cartellone (approntato in pochissimo tempo e presentato a fine febbraio) si è rivolto a tre titoli popolarissimi come La traviata di Giuseppe Verdi, La bohème di Giacomo Puccini e Carmen di Georges Bizet. E vabbé, siamo pur sempre un’Arena all’aperto e certe proposte più particolari sarebbero state improponibili per un’annata che mirava a conquistare un rapporto intenso e radicale (quasi populistico) con la città e il territorio, rapporto che si era in parte allentato negli ultimi anni (vedi anche questo mio vecchio editoriale pubblicato due anni fa su OperaClick). Il problema erano gli spettacoli: nemmeno a discutere per traviata, per cui si è deciso di riprendere il famosissimo e celebrato allestimento “degli specchi” con scene del compianto Josef Svoboda e regia di Henning Brockhaus. Lo spettacolo era stato creato nel 1992 (Violetta fu la compianta Giusy Devinu), aveva vinto il Premio Abbiati della Critica Italiana e, in seguito, era ritornato allo Sferisterio nel 1995 e 1996 (protagonista in entrambe le occasioni Luciana Serra, nel 1995 al suo debutto nel ruolo) per poi essere ripreso nel 1999 (debutto italiano come Violetta di Svetla Vassileva) e nel 2003 (con Eva Mei), oltre ad approdare in numerosissimi teatri italiani e stranieri (tra cui, negli ultimi anni, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Massimo di Palermo e il Palau des Artes di Valencia). Una ripresa (sia chiaro) doverosa e sacrosanta, a maggior ragione se si pensa che quest’anno cadeva il ventennale dalla creazione dell’allestimento in questione.
La nascita del Macerata Opera Festival 2012 è stata parecchio travagliata: esaurito il rapporto con Pier Luigi Pizzi, precedente direttore artistico (la cui uscita di scena, a onor del vero, poteva essere gestita in maniera alquanto migliore di come non sia avvenuto) lo Sferisterio è rimasto fino a gennaio 2012 senza una guida e, ovviamente, senza una stagione. Solo ai primi di gennaio si è ufficializzata la nuova direzione artistica di Francesco Micheli, il cui cartellone (approntato in pochissimo tempo e presentato a fine febbraio) si è rivolto a tre titoli popolarissimi come La traviata di Giuseppe Verdi, La bohème di Giacomo Puccini e Carmen di Georges Bizet. E vabbé, siamo pur sempre un’Arena all’aperto e certe proposte più particolari sarebbero state improponibili per un’annata che mirava a conquistare un rapporto intenso e radicale (quasi populistico) con la città e il territorio, rapporto che si era in parte allentato negli ultimi anni (vedi anche questo mio vecchio editoriale pubblicato due anni fa su OperaClick). Il problema erano gli spettacoli: nemmeno a discutere per traviata, per cui si è deciso di riprendere il famosissimo e celebrato allestimento “degli specchi” con scene del compianto Josef Svoboda e regia di Henning Brockhaus. Lo spettacolo era stato creato nel 1992 (Violetta fu la compianta Giusy Devinu), aveva vinto il Premio Abbiati della Critica Italiana e, in seguito, era ritornato allo Sferisterio nel 1995 e 1996 (protagonista in entrambe le occasioni Luciana Serra, nel 1995 al suo debutto nel ruolo) per poi essere ripreso nel 1999 (debutto italiano come Violetta di Svetla Vassileva) e nel 2003 (con Eva Mei), oltre ad approdare in numerosissimi teatri italiani e stranieri (tra cui, negli ultimi anni, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Massimo di Palermo e il Palau des Artes di Valencia). Una ripresa (sia chiaro) doverosa e sacrosanta, a maggior ragione se si pensa che quest’anno cadeva il ventennale dalla creazione dell’allestimento in questione.
 Si è andati sul sicuro, quindi, con Verdi, ma come fare per Puccini e Bizet? Micheli ha contattato due registi emergenti, dai nomi più legati alla prosa che alla lirica (genere che, comunque, entrambi avevano già frequentato), confidando nella loro capacità di adattarsi a budget ridotti all’osso per fornire un teatro di idee più che di scene. Serena Sinigaglia, regista di Carmen, ha peraltro esplicitamente dichiarato:
Si è andati sul sicuro, quindi, con Verdi, ma come fare per Puccini e Bizet? Micheli ha contattato due registi emergenti, dai nomi più legati alla prosa che alla lirica (genere che, comunque, entrambi avevano già frequentato), confidando nella loro capacità di adattarsi a budget ridotti all’osso per fornire un teatro di idee più che di scene. Serena Sinigaglia, regista di Carmen, ha peraltro esplicitamente dichiarato:
Oggi la mia generazione ha il dovere di fondare una nuova metodologia di lavoro eco-sostenibile. Non ci sono più i soldi di una volta, non si può più spendere o sperperare a vuoto. Bisogna operare nel rigore e cercare di produrre grandi opere con pochi mezzi. Questo vuol dire fare appello a tutte le nostre energie creative e sfruttare fino in fondo la forza evocativa che è caratteristica unica e straordinaria del teatro. Un teatro fatto di uomini e donne che non si risparmiano, un teatro fatto di idee e di storie, un teatro fatto di urgenze reali capaci di tornare a coinvolgere fino in fondo il pubblico che lo paga e lo sostiene.
Il risultato di queste due scommesse è stato notevole, pur tra le varie e prevedibili polemiche (minori di quanto mi aspettassi, a onor del vero) che hanno accolto la rilettura di una bohème in chiave sessantottina e, più ancora, una Carmen molto forte e intensa, che la Sinigaglia ha voluto gestire in una chabola (il corrispettivo spagnolo della favela).
 L’utilizzo di budget ridotti ha costretto la gestione a imporre un deciso risparmio sulla costruzione delle scene, avvalendosi del contributo degli studenti della locale Accademia di Belle Arti per la realizzazione di parte delle scenografie di bohème, consistenti nella presenza di numerosissimi cartelli di protesta, vista l’ambientazione nel maggio francese. Uno spostamento d’epoca, come è ovvio, non fa una regia: bohème può essere ambientata sullo spazio, sulla luna
L’utilizzo di budget ridotti ha costretto la gestione a imporre un deciso risparmio sulla costruzione delle scene, avvalendosi del contributo degli studenti della locale Accademia di Belle Arti per la realizzazione di parte delle scenografie di bohème, consistenti nella presenza di numerosissimi cartelli di protesta, vista l’ambientazione nel maggio francese. Uno spostamento d’epoca, come è ovvio, non fa una regia: bohème può essere ambientata sullo spazio, sulla luna o anche tra i maiali mannari volanti viola, ma lo stupore per un’ambientazione e una contestualizzazione inaspettata si esaurisce nei primi cinque minuti di spettacolo: il regista, se è bravo, deve quindi saper coordinare il lavoro di attori all’interno di una rilettura in cui non sono ammessi errori marchiani e per fare questo non serve a nulla sfruttare il fatto che bohème abbia un libretto talmento ben fatto che è difficile fare male… Per quanto perfetto nella struttura il libretto dell’opera di Puccini è comunque storicamente ben radicato nell’immaginario della Scapigliatura e, soprattutto, nella precisa contestualizzazione in cui è ambientata la vicenda. Leo Muscato ha quindi lavorato sul doppio binario della memoria del pubblico e del dato storico del libretto.
Probabilmente in quel soggetto (Puccini) ravvisava un po’ se stesso all’epoca degli stenti giovanili milanesi. Aveva mosso i suoi primissimi passi fra quei giovani poeti, musicisti e pittori che appena qualche anno prima avevano dato vita alla Scapigliatura. Quei giovani, animati da un forte sentimento di ribellione e di disprezzo nei confronti della cultura e del perbenismo borghese, avevano desunto il loro nome da una libera interpretazione del termine francese Bohème (vita da zingari), e si erano ispirati alla vita libertaria e anticonformista degli artisti parigini descritta proprio nel romanzo di Murger. Nel momento in cui l’opera di Puccini andava in scena per la prima volta, il sentimento nostalgico per quei tempi passati, era un sentimento diffuso. Probabilmente, fra gli stessi spettatori presenti in sala c’era chi in gioventù aveva vissuto in prima persona quel fermento culturale, artistico e politico; invece adesso sedeva imborghesita nei palchi del teatro. “O bella età d’inganni e d’utopie! Si crede, spera e tutto bello appare!” Già! Appare. Questa prima intuizione ci ha accompagnato in tutta la fase di elaborazione del progetto: bisognava puntare sulla memoria emotiva dei nostri spettatori.
 Per quanto riguarda il dato storico è interessante notare il parallelismo tra la Rivoluzione di Luglio e le ansie del maggio francese:
Per quanto riguarda il dato storico è interessante notare il parallelismo tra la Rivoluzione di Luglio e le ansie del maggio francese:
Parigi. 1830. Puccini aveva messo una distanza temporale fra la sua epoca e quella d’ambientazione di cui valeva la pena tenere conto. Ma cosa accadeva nel 1830, a Parigi? Era l’anno della Seconda Rivoluzione Francese (o Rivoluzione di Luglio, come i più la conoscono). Un anno di barricate e di sanpietrini divelti da migliaia di giovani scesi in strada per spodestare la monarchia. In quegli scontri caddero ottocento persone, e la loro morte servì appena a ottenere un cambio di dinastia: a un re Borbone, ne succedette uno della casa d’Orléans, quel Luigi Filippo citato da Puccini. […] I nostri protagonisti, vivono e agiscono una delle più grandi rivoluzioni culturali del ‘900, decisamente diversa dalla scapigliatura, ma altrettanto dirompente. E poiché nei primi due quadri li vediamo allegri, divertiti, divertenti e spensierati, non riusciamo a immaginarceli con i libri di Althusser e di Marcuse nelle tasche. Pensiamo a loro piuttosto come a quel folto numero di giovani che ha animato il Sessantotto nei suoi aspetti di rivoluzione diffusa, culturale e di costume. È così che li abbiamo immaginati.
 Richiamo nostalgico del pubblico in sala e presenza di giovani anticonformisti e rivoluzionari: la soffitta del I Atto diventa così, nella regia di Muscato, una comune abitata da quattro sgangherati ragazzotti, un po’ artisti e un po’ nullafacenti, la cui vita di espedienti ben si adatta al clima anni ’70 perseguito nello spettacolo. Mimì arriva in questo spazio (con una divisa da operaia) e resta letteralmente abbagliata dalla mole di oggetti contenuti, testimoni delle aspirazioni e dei sogni dei suoi abitanti. Quando Rodolfo dice di essere un poeta porge a Mimì dei fogli con, appunto, le sue poesie: l’espediente consente di movimentare il sempre statico dialogo tra i due giovani, ma permette anche di vedere come Mimì, lentamente, si appassioni al contenuto di quegli scritti, dove evidentemente si parla di libertà, di un mondo migliore, delle aspirazioni a una società più giusta e più equa. “Mi piaccion quelle cose, che han sì dolce malia […] quelle cose che han nome poesia” dichiarerà Mimì di lì a poco, e sono parole che acquistano un significato ben preciso, tenendo presente il clima politico del ’68. La giocosa spensieratezza che si respira in questo e nell’atto seguente appare quanto mai consona allo spirito della musica di Puccini: qualcuno è rimasto poco convinto di come il clima lieto e da musical del I e II Quadro viri in tragedia con stacco troppo evidente, ma in realtà è esattamente quello che si coglie nella musica di Puccini: Mimì non è moribonda quando entra in scena, è invece una giovane ragazza (parecchio intraprendente) che approfitta dell’unico momento in cui può trovare da solo il bell’inquilino del piano superiore per poter tentare un approccio con la scusa del lume che si è spento. Mimì è anche una donna che lavora e non è inopportuno ricordare che la tisi fu una malattia che, prima di interessare prostitute e donne dai costumi sessuali parecchio libertini, nacque nel XIX secolo come malattia dei polmoni, causata dalle scarsissime condizioni igieniche della nuova società industriale e diffusa per l’estrema povertà di lavoratori e operai. Molto spesso le grisettes (quale è Mimì) tentavano una scalata sociale accostandosi a un protettore (prostituendosi, di fatto) ed è così che la tisi divenne anche il mal d’amore con cui è nota ancora oggi. Come nota la musicologa Elena Filini “in Mimì si saldano due tipologie femminili. Il modello dell’operaia della nuova cultura industriale ed un nuovo tipo sociale che arriva sulla scena a seguito dell’epidemia di tubercolosi che invade l’Europa. In realtà l’una non esiste senza l’altra, perchè la tubercolosi è malattia della povertà, della malnutrizione, di inadeguati standard sanitari. Malattia da metropoli, dove si ammassano i sottoproletari.”
Richiamo nostalgico del pubblico in sala e presenza di giovani anticonformisti e rivoluzionari: la soffitta del I Atto diventa così, nella regia di Muscato, una comune abitata da quattro sgangherati ragazzotti, un po’ artisti e un po’ nullafacenti, la cui vita di espedienti ben si adatta al clima anni ’70 perseguito nello spettacolo. Mimì arriva in questo spazio (con una divisa da operaia) e resta letteralmente abbagliata dalla mole di oggetti contenuti, testimoni delle aspirazioni e dei sogni dei suoi abitanti. Quando Rodolfo dice di essere un poeta porge a Mimì dei fogli con, appunto, le sue poesie: l’espediente consente di movimentare il sempre statico dialogo tra i due giovani, ma permette anche di vedere come Mimì, lentamente, si appassioni al contenuto di quegli scritti, dove evidentemente si parla di libertà, di un mondo migliore, delle aspirazioni a una società più giusta e più equa. “Mi piaccion quelle cose, che han sì dolce malia […] quelle cose che han nome poesia” dichiarerà Mimì di lì a poco, e sono parole che acquistano un significato ben preciso, tenendo presente il clima politico del ’68. La giocosa spensieratezza che si respira in questo e nell’atto seguente appare quanto mai consona allo spirito della musica di Puccini: qualcuno è rimasto poco convinto di come il clima lieto e da musical del I e II Quadro viri in tragedia con stacco troppo evidente, ma in realtà è esattamente quello che si coglie nella musica di Puccini: Mimì non è moribonda quando entra in scena, è invece una giovane ragazza (parecchio intraprendente) che approfitta dell’unico momento in cui può trovare da solo il bell’inquilino del piano superiore per poter tentare un approccio con la scusa del lume che si è spento. Mimì è anche una donna che lavora e non è inopportuno ricordare che la tisi fu una malattia che, prima di interessare prostitute e donne dai costumi sessuali parecchio libertini, nacque nel XIX secolo come malattia dei polmoni, causata dalle scarsissime condizioni igieniche della nuova società industriale e diffusa per l’estrema povertà di lavoratori e operai. Molto spesso le grisettes (quale è Mimì) tentavano una scalata sociale accostandosi a un protettore (prostituendosi, di fatto) ed è così che la tisi divenne anche il mal d’amore con cui è nota ancora oggi. Come nota la musicologa Elena Filini “in Mimì si saldano due tipologie femminili. Il modello dell’operaia della nuova cultura industriale ed un nuovo tipo sociale che arriva sulla scena a seguito dell’epidemia di tubercolosi che invade l’Europa. In realtà l’una non esiste senza l’altra, perchè la tubercolosi è malattia della povertà, della malnutrizione, di inadeguati standard sanitari. Malattia da metropoli, dove si ammassano i sottoproletari.”
 Muscato di Mimì fa quello che è, ovvero un’operaia, che lavora in una fabbrica (la vediamo al III Quadro, è la Fonderie d’Enfer) che ovviamente non ha la tisi, ma che si è avvelenata respirando delle schifezze sul luogo di lavoro.
Muscato di Mimì fa quello che è, ovvero un’operaia, che lavora in una fabbrica (la vediamo al III Quadro, è la Fonderie d’Enfer) che ovviamente non ha la tisi, ma che si è avvelenata respirando delle schifezze sul luogo di lavoro.
Non tradiamo la grisette dei fiori finti di Murger, né quella pucciniana, né questa che portiamo in scena e che lavora in una fabbrica che le insozza i polmoni sino a condurla alla morte. Lei è soggetto storico privilegiato, non astratta categoria dell’anima, ma categoria sociale, semmai. Classe. Quella che nella seconda metà dell’800 si trova assembrata nelle fabbriche grigie di fumi velenosi e nei sobborghi mefitici delle metropoli industriali. Lei è il movimento reale delle cose, è il sacrificio umano che sorregge l’impalcatura di pensiero rivoluzionario che si muove lungo i binari della storia. E se in questa messa in scena, Rodolfo, Marcello, Schaunard, Colline e Musetta sono forse pretestuosamente “sessantottini”, Mimì è invece la mia scelta d’elezione. Era operaia e ultima ai tempi di Murger, di Puccini; è un’operaia che crepa in questa messa in scena; è la morte bianca che affolla i nostri tempi.
 Mimì, però, è sicuramente malata ma non è affatto moribonda alla sua entrata in scena. Mimì è una ragazza, come ve ne sono state e ve ne saranno tante, che ama divertirsi: puro divertimento è allora il II Quadro nella regia di Muscato, che del Café Momus fa un tipico locale zebrato anni ’60, con i coristi che ballano sui cubi e il “Tambur maggiore”, che entra al termine dell’atto, abbigliato come Frank Zappa, mentre la scena si chiude con una miriade di palloncini rossi, bianchi e blu che volano. Sono strizzate d’occhio al pubblico, vero, ma bisogna saperle fare perché riescano: in questo caso sono perfettamente riuscite, al pari del Valzer di Musetta, che viene risolto come un numero coreografico (quasi alla Wanda Osiris) con tanto di boys innamorati, ovviamente con canotte zebrate. Non è nemmeno vero che questa atmosfera quasi da musical strida con la drammaticità degli atti seguenti: la spensieratezza della gioventù, il senso del mondo che è stretto nella propria mano (che si prova a vent’anni e mai più) è già presente nella musica di Puccini, così come il lento decadere dei sogni e delle aspirazioni. La novità di bohème è anche in questo morire che arriva, al tempo stesso, con delicatezza e fragore: fragore perché sconvolge la vita di una comunità di ragazzi trasportandoli nel mondo “adulto”, oltre il tempo degli ideali; delicatezza perché Mimì si ammala e si consuma con pudore, così come muoiono le persone nel mondo di tutti i giorni.
Mimì, però, è sicuramente malata ma non è affatto moribonda alla sua entrata in scena. Mimì è una ragazza, come ve ne sono state e ve ne saranno tante, che ama divertirsi: puro divertimento è allora il II Quadro nella regia di Muscato, che del Café Momus fa un tipico locale zebrato anni ’60, con i coristi che ballano sui cubi e il “Tambur maggiore”, che entra al termine dell’atto, abbigliato come Frank Zappa, mentre la scena si chiude con una miriade di palloncini rossi, bianchi e blu che volano. Sono strizzate d’occhio al pubblico, vero, ma bisogna saperle fare perché riescano: in questo caso sono perfettamente riuscite, al pari del Valzer di Musetta, che viene risolto come un numero coreografico (quasi alla Wanda Osiris) con tanto di boys innamorati, ovviamente con canotte zebrate. Non è nemmeno vero che questa atmosfera quasi da musical strida con la drammaticità degli atti seguenti: la spensieratezza della gioventù, il senso del mondo che è stretto nella propria mano (che si prova a vent’anni e mai più) è già presente nella musica di Puccini, così come il lento decadere dei sogni e delle aspirazioni. La novità di bohème è anche in questo morire che arriva, al tempo stesso, con delicatezza e fragore: fragore perché sconvolge la vita di una comunità di ragazzi trasportandoli nel mondo “adulto”, oltre il tempo degli ideali; delicatezza perché Mimì si ammala e si consuma con pudore, così come muoiono le persone nel mondo di tutti i giorni.
 Nel III Quadro si vede finalmente la fabbrica (la Fonderie d’Enfer) in cui lavora Mimì e si capisce il livello tecnico di Muscato nell’utilizzo dello spazio, pregio che condivide con la Sinigaglia (ne parlo poi) e che apprezzo particolarmente alle prese con un palcoscenico insidioso come lo Sferisterio (le scene sono di Federica Parolini): lo spazio ristretto della comune iniziale si allarga nel Cafè Momus, interessando anche le zone laterali del palcoscenico, e più ancora in questo III Quadro, con l’inferriata della Fonderie che occupa quasi per intero i 92 metri del lunghissimo palco dell’Arena. La fabbrica è occupata e si è appena svolta una manifestazione violenta: lo capiamo dai sanpietrini a terra e dalla presenza dei poliziotti in assetto anti-sommossa; particolare ironia (tenendo presente che operai e studenti hanno preso possesso dell’edificio) acquistano quindi le parole di Marcello “siam qui da un mese, di quell’oste alle spese” nonché “Io pingo quei guerrieri sulla facciata” (e i guerrieri sono manifesti di protesta e di lotta con slogan contro l’inquinamento e il veleno della fonderia). Gli operai che vediamo indossano la stessa divisa blu di Mimì (costumi di Silvia Aymonino), ma questa informazione non è fornita in maniera esplicita e, per così dire, “violenta” nei confronti dello spettatore, che può anche non notare questo particolare (in una chiave di lettura dello spettacolo più superficiale) senza perdere il piacere della narrazione di una storia: detto in parole povere non è essenziale, per godere dell’allestimento, cogliere il nesso che vuole Mimì operaia della stessa fabbrica che vediamo occupata e accusata di avvelenare la popolazione. Molto carina anche l’idea di non far lasciare Marcello e Musetta nel Quartetto finale ma di far seguire un appassionato bacio (con sveltina nel furgone) al loro furioso litigio.
Nel III Quadro si vede finalmente la fabbrica (la Fonderie d’Enfer) in cui lavora Mimì e si capisce il livello tecnico di Muscato nell’utilizzo dello spazio, pregio che condivide con la Sinigaglia (ne parlo poi) e che apprezzo particolarmente alle prese con un palcoscenico insidioso come lo Sferisterio (le scene sono di Federica Parolini): lo spazio ristretto della comune iniziale si allarga nel Cafè Momus, interessando anche le zone laterali del palcoscenico, e più ancora in questo III Quadro, con l’inferriata della Fonderie che occupa quasi per intero i 92 metri del lunghissimo palco dell’Arena. La fabbrica è occupata e si è appena svolta una manifestazione violenta: lo capiamo dai sanpietrini a terra e dalla presenza dei poliziotti in assetto anti-sommossa; particolare ironia (tenendo presente che operai e studenti hanno preso possesso dell’edificio) acquistano quindi le parole di Marcello “siam qui da un mese, di quell’oste alle spese” nonché “Io pingo quei guerrieri sulla facciata” (e i guerrieri sono manifesti di protesta e di lotta con slogan contro l’inquinamento e il veleno della fonderia). Gli operai che vediamo indossano la stessa divisa blu di Mimì (costumi di Silvia Aymonino), ma questa informazione non è fornita in maniera esplicita e, per così dire, “violenta” nei confronti dello spettatore, che può anche non notare questo particolare (in una chiave di lettura dello spettacolo più superficiale) senza perdere il piacere della narrazione di una storia: detto in parole povere non è essenziale, per godere dell’allestimento, cogliere il nesso che vuole Mimì operaia della stessa fabbrica che vediamo occupata e accusata di avvelenare la popolazione. Molto carina anche l’idea di non far lasciare Marcello e Musetta nel Quartetto finale ma di far seguire un appassionato bacio (con sveltina nel furgone) al loro furioso litigio.
 Il IV Quadro è quello che ha destato in qualcuno le maggiori perplessità anche se, onestamente, non ne capisco il motivo: la soffitta del I Quadro è ora vuota e desolata, perché i quattro sono stati sfrattati e, durante il duetto tra Rodolfo e Marcello, li vediamo impacchettare le loro cose nella scena vuota. È un escamotage, ovviamente, dato che la scena serve vuota per la seconda parte dell’atto, ma è un escamotage che funziona e che, soprattutto, permette di preparare al meglio il colpo di scena dell’ingresso di Mimì su di un letto di ospedale. All’arrivo di Musetta i quattro giovani la seguono e, immaginiamo, portano Mimì al pronto soccorso, dove viene ricoverata. La scena successiva non rappresenta l’ingresso nella soffitta di Mimì su di un letto, come qualcuno ha ingenuamente pensato, ma un semplice cambio di luogo: a destra è il letto di Mimì e a sinistra la sala d’attesa, con tanto di Madonnina (di quelle semplici, anche un po’ squallide, che si trovano negli angoli degli ospedali) cui si rivolgerà Musetta nella sua preghiera. Nella sala d’attesa, seduti su tre sedie poste in fila con la tipica tristezza dei luoghi di ricovero, Musetta spiega ai ragazzi come ha trovato Mimì, chiedendo loro se hanno qualcosa in casa: anche in questo caso non si manca di logica, pur non essendo più i personaggi nella soffitta dei bohémiens, perché (e chi ha avuto l’esperienza di ricoveri improvvisi lo sa benissimo) passato lo shock dell’allettamento i parenti e gli amici si preoccupano di portare in ospedale cibo e effetti personali dell’ammalato. Le infermiere impediscono dapprima a Rodolfo di avvicinarsi all’ammalata, perché devono attacare flebo e respiratore, così come gli amici (al termine) tratterranno Rodolfo mentre i medici copriranno il cadavere di Mimì con un lenzuolo bianco e lo porteranno via. Per un attimo, sulle battute finali, si illumina un cartello di protesta: “Avec nous combat pour vivre libre”.
Il IV Quadro è quello che ha destato in qualcuno le maggiori perplessità anche se, onestamente, non ne capisco il motivo: la soffitta del I Quadro è ora vuota e desolata, perché i quattro sono stati sfrattati e, durante il duetto tra Rodolfo e Marcello, li vediamo impacchettare le loro cose nella scena vuota. È un escamotage, ovviamente, dato che la scena serve vuota per la seconda parte dell’atto, ma è un escamotage che funziona e che, soprattutto, permette di preparare al meglio il colpo di scena dell’ingresso di Mimì su di un letto di ospedale. All’arrivo di Musetta i quattro giovani la seguono e, immaginiamo, portano Mimì al pronto soccorso, dove viene ricoverata. La scena successiva non rappresenta l’ingresso nella soffitta di Mimì su di un letto, come qualcuno ha ingenuamente pensato, ma un semplice cambio di luogo: a destra è il letto di Mimì e a sinistra la sala d’attesa, con tanto di Madonnina (di quelle semplici, anche un po’ squallide, che si trovano negli angoli degli ospedali) cui si rivolgerà Musetta nella sua preghiera. Nella sala d’attesa, seduti su tre sedie poste in fila con la tipica tristezza dei luoghi di ricovero, Musetta spiega ai ragazzi come ha trovato Mimì, chiedendo loro se hanno qualcosa in casa: anche in questo caso non si manca di logica, pur non essendo più i personaggi nella soffitta dei bohémiens, perché (e chi ha avuto l’esperienza di ricoveri improvvisi lo sa benissimo) passato lo shock dell’allettamento i parenti e gli amici si preoccupano di portare in ospedale cibo e effetti personali dell’ammalato. Le infermiere impediscono dapprima a Rodolfo di avvicinarsi all’ammalata, perché devono attacare flebo e respiratore, così come gli amici (al termine) tratterranno Rodolfo mentre i medici copriranno il cadavere di Mimì con un lenzuolo bianco e lo porteranno via. Per un attimo, sulle battute finali, si illumina un cartello di protesta: “Avec nous combat pour vivre libre”.
Oltre a ispirarsi al romanzo originale di Henri Murger (in cui Mimì muore ricoverata e Rodolphe, a causa di un equivoco, non riesce a vederla per l’ultima volta) questa scelta espressiva appare particolarmente efficace nel dipingere un ospedale in cui i medici sono sempre assenti (in fondo, penseranno, chi se ne frega di questa operaia, tanto ormai non c’è più niente da fare), rendendo il finale ancora più straziante. Chi ha vissuto l’esperienza dell’agonia e della morte di un parente in ospedale non mancherà quindi di essere profondamente toccato da questo spettacolo.
 L’aspetto che ho trovato più interessante di questa bohème targata Muscato (così come della Carmen nella particolare visione della Sinigaglia) è la capacità di “raccontare” una storia; sembra una banalità ma, in fondo, il dato narrativo spesso viene sacrificato negli allestimenti lirici in nome di eccessivi simbolismi e/o riletture con pesanti sovrastrutture politiche. La politica e la riflessione sulla società contemporanea sono presenti sia nello spettacolo di Muscato che in quello della Sinigaglia, ma la loro capacità narrativa li rende immediatamente fruibili, dimostrando come il teatro d’opera (a dispetto di sterili populismi o di chi lo considera solo un “diletto per borghesi”) possa contribuire a generare discussione e riflessione. In questo, certamente, la Carmen riletta da Serena Sinigaglia appare meno semplice, immediata e comunicativa della bohème di Muscato: se bohème si giovava della bellezza estetica di scene affascinanti nella loro voluta e insistita psichedelia di colori, Carmen non è bella perché l’appagamento dell’estetica non è quello che cerca la Sinigaglia, preferendo concentrarsi su di una visione forte e intensa, per niente incline al bozzettismo di tradizione, in questo aiutata dai volutamente anonimi e squallidi costumi di Federica Ponissi, che ricreano con le tonalità del sabbia un mondo di polvere e terra, povero e straniato. Non condivido l’opinione di chi ha definito questa Carmen come il punto debole della stagione: è uno spettacolo forse poco immediato, ma comunque molto interessante.
L’aspetto che ho trovato più interessante di questa bohème targata Muscato (così come della Carmen nella particolare visione della Sinigaglia) è la capacità di “raccontare” una storia; sembra una banalità ma, in fondo, il dato narrativo spesso viene sacrificato negli allestimenti lirici in nome di eccessivi simbolismi e/o riletture con pesanti sovrastrutture politiche. La politica e la riflessione sulla società contemporanea sono presenti sia nello spettacolo di Muscato che in quello della Sinigaglia, ma la loro capacità narrativa li rende immediatamente fruibili, dimostrando come il teatro d’opera (a dispetto di sterili populismi o di chi lo considera solo un “diletto per borghesi”) possa contribuire a generare discussione e riflessione. In questo, certamente, la Carmen riletta da Serena Sinigaglia appare meno semplice, immediata e comunicativa della bohème di Muscato: se bohème si giovava della bellezza estetica di scene affascinanti nella loro voluta e insistita psichedelia di colori, Carmen non è bella perché l’appagamento dell’estetica non è quello che cerca la Sinigaglia, preferendo concentrarsi su di una visione forte e intensa, per niente incline al bozzettismo di tradizione, in questo aiutata dai volutamente anonimi e squallidi costumi di Federica Ponissi, che ricreano con le tonalità del sabbia un mondo di polvere e terra, povero e straniato. Non condivido l’opinione di chi ha definito questa Carmen come il punto debole della stagione: è uno spettacolo forse poco immediato, ma comunque molto interessante.
 Con queste parole la stessa regista descrive lo spazio scenico ideato da Maria Spazzi (una sorta di discarica delimitata da transenne) in cui l’intera vicenda si ambienta:
Con queste parole la stessa regista descrive lo spazio scenico ideato da Maria Spazzi (una sorta di discarica delimitata da transenne) in cui l’intera vicenda si ambienta:
Una periferia deflagrata, interrotta da linee di transenne che vengono mosse a seconda dei luoghi che si vanno ad evocare. […] “Carmen” è la storia di un confine che si rompe, di un limite che si sgretola. E’ l’eterno conflitto morale, sociale, psicologico tra l’ordine (oppressivo, violento, mortifero) e la libertà (anarchica, disordinata, sfrenata). Le periferie delle metropoli del mondo si assomigliano tutte: degrado, desolazione, luoghi di confine dove sembra essere passata (e magari ci è passata davvero) la morte, la distruzione, l’annientamento. In questi luoghi trovi baraccopoli e case popolari dove vivono a migliaia i disgraziati del mondo. Quell’enorme percentuale di poveri che cerca di sopravvivere con niente. Pensiamo alle favelas, alle bidonville, alle banlieu, a quei luoghi di confine dove tutte le contraddizioni delle nostre società, un tempo opulenta, esplodono in fenomeni di violenza. Oggi, in Europa, la più grande concentrazione gitana si trova, pensate il caso!, proprio nella chabola (corrispettivo spagnolo di favela) di Siviglia. La passione tra Carmen e Josè esplode proprio in uno di questi “non luoghi”, abitati da forti tensioni sociali. Josè è un tutore dell’ordine, Carmen è una zingara. Polizia e gitani. Ecco, lo scontro. Josè è scappato dalla sua città natale e si è arruolato per nascondere un fatto gravissimo: ha ucciso un uomo durante una rissa, lo ha accoltellato a morte.
 La chabola è sormontata da squallide decorazioni rosse, un addobbo festivo (richiamo alla corrida del IV Atto) che durante il preludio all’atto finale e durante il duetto conclusivo tra i due protagonisti verranno progressivamente ritirate contro il muro fino a trafiggerlo, non diversamente da come le banderillos trafiggono il toro durante la corrida. In scena ci sono solo zingari e poliziotti, immagine di una società violenta e di un non-luogo al di fuori delle leggi, in cui tutto è permesso. Anche Escamillo è uno zingaro, uno che viene dal basso e che “ce l’ha fatta”, una sorta di Maradona idolatrato dai suoi fan in maniera istintiva e viscerale. Non è un caso che lui inviti tutti i suoi ex compagni alla corrida che lo vedrà protagonista, perché Escamillo non dimentica le sue origini umili. La Sinigaglia utilizza anche il simbolismo, ma lo utilizza con intelligenza: oltre alle decorazioni rosse che sovrastano la platea (e creano un suggestivo colpo d’occhio fin dall’ingresso allo Sferisterio) si assiste a un palese richiamo folklorico nelle prefiche che, prese direttamente dalle settimane sante sivigliane, sottolineano i momenti in cui è presente Micaela, simboleggiando l’ordine immutabile dell’universo borghese (di cui Micaela è rappresentante) che non può trovare spazio nello squallido universo della chabola.
La chabola è sormontata da squallide decorazioni rosse, un addobbo festivo (richiamo alla corrida del IV Atto) che durante il preludio all’atto finale e durante il duetto conclusivo tra i due protagonisti verranno progressivamente ritirate contro il muro fino a trafiggerlo, non diversamente da come le banderillos trafiggono il toro durante la corrida. In scena ci sono solo zingari e poliziotti, immagine di una società violenta e di un non-luogo al di fuori delle leggi, in cui tutto è permesso. Anche Escamillo è uno zingaro, uno che viene dal basso e che “ce l’ha fatta”, una sorta di Maradona idolatrato dai suoi fan in maniera istintiva e viscerale. Non è un caso che lui inviti tutti i suoi ex compagni alla corrida che lo vedrà protagonista, perché Escamillo non dimentica le sue origini umili. La Sinigaglia utilizza anche il simbolismo, ma lo utilizza con intelligenza: oltre alle decorazioni rosse che sovrastano la platea (e creano un suggestivo colpo d’occhio fin dall’ingresso allo Sferisterio) si assiste a un palese richiamo folklorico nelle prefiche che, prese direttamente dalle settimane sante sivigliane, sottolineano i momenti in cui è presente Micaela, simboleggiando l’ordine immutabile dell’universo borghese (di cui Micaela è rappresentante) che non può trovare spazio nello squallido universo della chabola.
 Il dissidio tra gli obblighi familiari imposti a José dalla famiglia e il suo furore geloso e istintivo nei confronti di Carmen è alla base del corto-circuito di violenza che esploderà nel duetto finale:
Il dissidio tra gli obblighi familiari imposti a José dalla famiglia e il suo furore geloso e istintivo nei confronti di Carmen è alla base del corto-circuito di violenza che esploderà nel duetto finale:
Josè non è l’ingenuo amoroso che casca tra le grinfie della furba gitana. Josè è un uomo passionale e violento, un uomo all’altezza di Carmen, con una sola grande differenza. I luoghi da cui proviene sono di stampo piccolo borghese, intrisi di valori cattolici e di sensi di colpa. La figura della madre è centrale per entrare a pieno nella psicologia di questo personaggio. La madre è il monito, è quella pressione feroce che porta Josè a perdere il controllo. L’emissaria di questa cultura opprimente e bigotta è Micaela. Micaela, altro personaggio straordinario di “Carmen”. Josè e Micaela sono cresciuti insieme. Fin da bambini. Insieme. Lei si è integrata in quel mondo di regole e precetti, lui, no. Si conoscono da sempre, da sempre si vogliono bene. Per Micaela sarebbe naturale sposare Josè. Per Josè, no. Josè è irrequieto, insoddisfatto, a tratti violento. Ma per il mondo attorno, per la madre, la cosa giusta è il matrimonio. Punto e basta.
 In questo universo Carmen non è, ovviamente, quella della tradizione: mascolina, a tratti volgare, sicura di sé, erotica non perché bella, ma perché “maschile” nella sua indipendenza ostentata, Carmen è una zingara tatuata che ha imparato a difendersi da sola e che riconosce in Josè un uomo che anela (o potrebbe anelare) alla stessa libertà che lei desidera. Il loro legame è fisico, intenso: tanto per citare un solo esempio, nel II Atto lui la ammanetta a una transenna per obbligarla ad ascoltare la sua aria del fiore. Questo legame continua nel grande scontro del Finale IV, che la Sinigaglia imposta come un duello a colpi di navaja: Carmen sa che se vuole vivere deve liberarsi di questo maschio violento e incontrollabile e, a dispetto del destino, lo sfida con il coltello che le lasciano Frasquita e Mercedes, mentre i militari assistono indifferenti allo scontro. Carmen viene ferita una, due, tre volte e invano chiede aiuto ai soldati, che se ne vanno pensando, magari, che ora c’è una puttana di meno da gestire: agonizzante, Carmen continua a rifiutare le profferte di José che, imperterrito, colpisce più e più volte, fino a infierire sul cadavere dopo il lancio dell’anello, in una rappresentazione molto intensa della violenza dell’uomo sulla donna e in un esempio assai riuscito di teatro “etico” (se ancora questa parola ha un senso) e “civile”.
In questo universo Carmen non è, ovviamente, quella della tradizione: mascolina, a tratti volgare, sicura di sé, erotica non perché bella, ma perché “maschile” nella sua indipendenza ostentata, Carmen è una zingara tatuata che ha imparato a difendersi da sola e che riconosce in Josè un uomo che anela (o potrebbe anelare) alla stessa libertà che lei desidera. Il loro legame è fisico, intenso: tanto per citare un solo esempio, nel II Atto lui la ammanetta a una transenna per obbligarla ad ascoltare la sua aria del fiore. Questo legame continua nel grande scontro del Finale IV, che la Sinigaglia imposta come un duello a colpi di navaja: Carmen sa che se vuole vivere deve liberarsi di questo maschio violento e incontrollabile e, a dispetto del destino, lo sfida con il coltello che le lasciano Frasquita e Mercedes, mentre i militari assistono indifferenti allo scontro. Carmen viene ferita una, due, tre volte e invano chiede aiuto ai soldati, che se ne vanno pensando, magari, che ora c’è una puttana di meno da gestire: agonizzante, Carmen continua a rifiutare le profferte di José che, imperterrito, colpisce più e più volte, fino a infierire sul cadavere dopo il lancio dell’anello, in una rappresentazione molto intensa della violenza dell’uomo sulla donna e in un esempio assai riuscito di teatro “etico” (se ancora questa parola ha un senso) e “civile”.
Questa zingara non è bella, ha però qualcosa che vale molto più della bellezza, è libera, è assolutamente e totalmente se stessa. Questa è la sua forza, questa è la sua irresistibile bellezza. Carmen è il carisma e la forza di chi vive la vita, succhiandola fino all’ultima goccia. E’ una donna, è una zingara, basterebbe questo a renderla schiava di altri. Invece Carmen è libera. Libera anche di essere crudele. Libera di essere pienamente ciò che sente. Appartiene ad una categoria sociale che non riconosce le regole della società borghese, e ne rivendica delle altre, con la furbizia e la scaltrezza tipica di chi ha imparato ad arrangiarsi e a insinuarsi tra le pieghe di un mondo corrotto e disonesto.
 Il Finale vero e proprio è poi commovente: Lillas Pastia (che per l’intera durata dello spettacolo è stato rappresentato come uno zingaro alcolizzato e forse ritardato, escluso tra gli esclusi, che solo con Carmen aveva un rapporto di umanità e, forse, di amicizia) vede lo scempio della compagna e si affretta a sostenerne il corpo, come in una moderna pietà laica. Micaela assiste inorridita al massacro di Carmen ma, in fondo, sa che così si è liberata della rivale e dell’incubo che impediva la realizzazione del suo sogno borghese. Mentre José chiama i poliziotti per essere arrestato (gli stessi poliziotti che se ne erano invece andati, permettendo all’ex collega di massacrare con calma Carmen) Micaela, freneticamente, prende il coltello e lo pone nella mano di Lillas Pastia. “Chi se ne importa di quell’imbecille, che venga accusato lui” sembra dirci, mentre allontana e porta via José. Siamo sicuri che anche Micaela non sia destinata alla stessa fine di Carmen? Chissà: il raptus di José offre ben poche rassicurazioni al riguardo.
Il Finale vero e proprio è poi commovente: Lillas Pastia (che per l’intera durata dello spettacolo è stato rappresentato come uno zingaro alcolizzato e forse ritardato, escluso tra gli esclusi, che solo con Carmen aveva un rapporto di umanità e, forse, di amicizia) vede lo scempio della compagna e si affretta a sostenerne il corpo, come in una moderna pietà laica. Micaela assiste inorridita al massacro di Carmen ma, in fondo, sa che così si è liberata della rivale e dell’incubo che impediva la realizzazione del suo sogno borghese. Mentre José chiama i poliziotti per essere arrestato (gli stessi poliziotti che se ne erano invece andati, permettendo all’ex collega di massacrare con calma Carmen) Micaela, freneticamente, prende il coltello e lo pone nella mano di Lillas Pastia. “Chi se ne importa di quell’imbecille, che venga accusato lui” sembra dirci, mentre allontana e porta via José. Siamo sicuri che anche Micaela non sia destinata alla stessa fine di Carmen? Chissà: il raptus di José offre ben poche rassicurazioni al riguardo.
 Ci sarebbero poi da spendere due parole sull’altissimo livello tecnico dell’allestimento della Sinigaglia: lo spazio (come già nello spettacolo di Muscato) viene utilizzato con estrema intelligenza per ricreare sul palcoscenico dell’Arena la chabola, delimitata da una serie di transenne di ferro continuamente mosse dagli impegnatissimi membri del Balletto Civile di Parma nella creazione dei vari ambienti dell’azione. È ammirevole come la Sinigaglia riesca a trovare soluzioni interessanti per i numerosi momenti problematici dell’opera: nella piazza iniziale non passa nessuno e il commento ironico dei militari sulla variegata umanità appare come l’affermazione del proprio potere coercitivo; il duetto tra José e Micaela (così lungo e così statico nel I Atto) evoca un paradiso e una benedizione borghesi rappresentati dai gesti rituali delle prefiche; il musicalmente scintillante (ma scenicamente così difficile) quintetto del II Atto termina in un volgare e acceso balletto delle zingare (quasi un richiamo alla struttura da opéra cominque dell’opera), che indossano gli abiti nuovi regalati dagli uomini per convincerle a seguirli nella prossima impresa; la sempre difficile sfilata dei toreri viene solo immaginata dal pubblico sulla base dei movimenti del coro al proscenio, con il solo Escamillo ad apparire (entrando dalla platea) perché, zingaro anch’egli, si stacca dal corteo ufficiale per salutare i suoi compagni venuti a sostenerlo. A proposito di questo andrà anche notato che, di per sé, alcune soluzioni tecniche e visive dell’allestimento non sono nuove: la prevaricazione femminile era stata vista anche nello spettacolo di Calixto Bieito a Barcellona, Palermo e, più recentemente, Venezia (e anche lì Carmen entrava parlando al telefono, anche se in una cabina e non al cellulare come nello spettacolo maceratese); le entrate dalla platea (espediente abbastanza abusato) erano presenti nell’allestimento di Gilbert Deflo visto a Macerata nel 1994, 1998 e 2002; la presenza delle prefiche, infine, appariva simile nella produzione di Emma Dante alla Scala. Poco male, visto che la novità (se di questo si può parlare) della Sinigaglia non è in questi elementi, ma nell’utilizzo che di essi viene fatto, creando un allestimento di enorme forza espressiva in cui, per inciso, sia il coro che i solisti recitano divinamente, a cominciare dalla protagonista, Veronica Simeoni, che si è inserita con molta sensibilità in una visione lontana dalla “porcaggine” di tradizione.
Ci sarebbero poi da spendere due parole sull’altissimo livello tecnico dell’allestimento della Sinigaglia: lo spazio (come già nello spettacolo di Muscato) viene utilizzato con estrema intelligenza per ricreare sul palcoscenico dell’Arena la chabola, delimitata da una serie di transenne di ferro continuamente mosse dagli impegnatissimi membri del Balletto Civile di Parma nella creazione dei vari ambienti dell’azione. È ammirevole come la Sinigaglia riesca a trovare soluzioni interessanti per i numerosi momenti problematici dell’opera: nella piazza iniziale non passa nessuno e il commento ironico dei militari sulla variegata umanità appare come l’affermazione del proprio potere coercitivo; il duetto tra José e Micaela (così lungo e così statico nel I Atto) evoca un paradiso e una benedizione borghesi rappresentati dai gesti rituali delle prefiche; il musicalmente scintillante (ma scenicamente così difficile) quintetto del II Atto termina in un volgare e acceso balletto delle zingare (quasi un richiamo alla struttura da opéra cominque dell’opera), che indossano gli abiti nuovi regalati dagli uomini per convincerle a seguirli nella prossima impresa; la sempre difficile sfilata dei toreri viene solo immaginata dal pubblico sulla base dei movimenti del coro al proscenio, con il solo Escamillo ad apparire (entrando dalla platea) perché, zingaro anch’egli, si stacca dal corteo ufficiale per salutare i suoi compagni venuti a sostenerlo. A proposito di questo andrà anche notato che, di per sé, alcune soluzioni tecniche e visive dell’allestimento non sono nuove: la prevaricazione femminile era stata vista anche nello spettacolo di Calixto Bieito a Barcellona, Palermo e, più recentemente, Venezia (e anche lì Carmen entrava parlando al telefono, anche se in una cabina e non al cellulare come nello spettacolo maceratese); le entrate dalla platea (espediente abbastanza abusato) erano presenti nell’allestimento di Gilbert Deflo visto a Macerata nel 1994, 1998 e 2002; la presenza delle prefiche, infine, appariva simile nella produzione di Emma Dante alla Scala. Poco male, visto che la novità (se di questo si può parlare) della Sinigaglia non è in questi elementi, ma nell’utilizzo che di essi viene fatto, creando un allestimento di enorme forza espressiva in cui, per inciso, sia il coro che i solisti recitano divinamente, a cominciare dalla protagonista, Veronica Simeoni, che si è inserita con molta sensibilità in una visione lontana dalla “porcaggine” di tradizione.
Una scelta “povera”, semplice, onesta e radicale, dettata dai tempi che viviamo ma soprattutto dall’assoluta convinzione che, alla fine, questo sia il teatro. Andare a fondo, restituire l’essenza della vita, attivare la fantasia e l’immaginazione del pubblico, coinvolgendolo emotivamente e rendendolo realmente partecipe di ciò che vede. Un rito laico che ci lascia tutti un po’ più ricchi. Ricchi di una ricchezza che conta molto più dell’euro e dello spread.
 In poco tempo allo Sferisterio si è dunque riusciti ad allestire due spettacoli che magari non saranno epocali, che probabilmente non segneranno la storia delle produzioni liriche, ma che permettono allo spettatore di pensare e riflettere sulla società in cui vive, il tutto mentre gli viene raccontata, semplicemente, una storia: una storia in cui si parla delle illusioni perdute della gioventù (età che “non ha che una stagione”, come notava Murger nelle Scenes de la vie de bohème) o della prevaricazione odierna nei confronti delle donne o, in generale, delle fasce più deboli della società. Due spettacoli che permettono ancora di capire perché l’opera possa essere considerata uno degli spettacoli più belli, complessi e affascinanti di sempre: perché parla di ognuno di noi. E poco male se per una volta non si sono visti gli scialli, i vestiti dell’Ottocento, le nacchere e gli sgonnellamenti: ho avuto l’impressione di vedere, al loro posto, delle storie di esseri umani, raccontate in una maniera tale da evitare la provocazione sterile e fine a se stessa per essere, anzi, gestite in perfetto accordo con la musica. Si tratta di un risultato che non avrei mai creduto possibile, visto lo scarso tempo con cui il Macerata Opera Festival 2012 è stato allestito. Ed ecco anche il perché di questo lungo post.
In poco tempo allo Sferisterio si è dunque riusciti ad allestire due spettacoli che magari non saranno epocali, che probabilmente non segneranno la storia delle produzioni liriche, ma che permettono allo spettatore di pensare e riflettere sulla società in cui vive, il tutto mentre gli viene raccontata, semplicemente, una storia: una storia in cui si parla delle illusioni perdute della gioventù (età che “non ha che una stagione”, come notava Murger nelle Scenes de la vie de bohème) o della prevaricazione odierna nei confronti delle donne o, in generale, delle fasce più deboli della società. Due spettacoli che permettono ancora di capire perché l’opera possa essere considerata uno degli spettacoli più belli, complessi e affascinanti di sempre: perché parla di ognuno di noi. E poco male se per una volta non si sono visti gli scialli, i vestiti dell’Ottocento, le nacchere e gli sgonnellamenti: ho avuto l’impressione di vedere, al loro posto, delle storie di esseri umani, raccontate in una maniera tale da evitare la provocazione sterile e fine a se stessa per essere, anzi, gestite in perfetto accordo con la musica. Si tratta di un risultato che non avrei mai creduto possibile, visto lo scarso tempo con cui il Macerata Opera Festival 2012 è stato allestito. Ed ecco anche il perché di questo lungo post.
Le foto dei due allestimenti, ancora in scena al Macerata Opera Festival 2012 fino al 12 agosto, sono di Alfredo Tabocchini e sono riconoscibili i protagonisti di bohème (Francesco Meli, Carmen Giannattasio, Damiano Salerno, Serena Gamberoni, Andrea Concetti e Andrea Porta) e Carmen (Veronica Simeoni, Roberto Aronica, Alessandra Marianelli e Gezim Mishketa); il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana sono guidate da Paolo Arrivabeni per bohème e Dominique Trottein per Carmen. Le dichiarazioni di Leo Muscato e Serena Sinigaglia sono tratte dalle rispettive Note di Regia presenti nel sito del Macerata Opera Festival.
Clicca sul banner per leggere tutti gli articoli della rubrica “Parliamo di Regia”:

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia License.















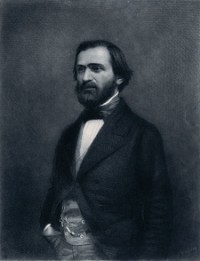





#1 di icittadiniprimaditutto il 1 agosto 2012 - 09:23
Reblogged this on i cittadini prima di tutto.