Articoli con tag Approfondimenti
Don Checco di Nicola de Giosa
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Don Checco, Nicola De Giosa, Operisti minori dell'Ottocento il 27 aprile 2013
 Ricevo e pubblico volentieri da Paola Ciarlantini il seguente articolo sulla ripresa in epoca moderna dell’opera Don Checco del compositore barese Nicola de Giosa, avvenuta allo Showville di Bari il 15 marzo 2013. Il lavoro, composto nel 1850, era famoso per essere l’opera comica preferita di Ferdinando II di Borbone. Sono peraltro molto felice che tale riproposta sia avvenuta grazie alla direzione aristica di Angelo Cavallaro, che a Jesi ricordo promotore instancabile di tanti recuperi della produzione musicale sconosciuta del XIX secolo.
Ricevo e pubblico volentieri da Paola Ciarlantini il seguente articolo sulla ripresa in epoca moderna dell’opera Don Checco del compositore barese Nicola de Giosa, avvenuta allo Showville di Bari il 15 marzo 2013. Il lavoro, composto nel 1850, era famoso per essere l’opera comica preferita di Ferdinando II di Borbone. Sono peraltro molto felice che tale riproposta sia avvenuta grazie alla direzione aristica di Angelo Cavallaro, che a Jesi ricordo promotore instancabile di tanti recuperi della produzione musicale sconosciuta del XIX secolo.
L’atteso ritorno sulle scene del Don Checco di Nicola De Giosa (di PAOLA CIARLANTINI)
L’opera Don Checco di Nicola De Giosa (Bari 1819-1885) è stata, secondo Andrea Lanza, curatore della voce sul compositore per il The New Grove Dictionary of Music and Musicians (il più autorevole dei dizionari musicali correnti), “his masterpiece and one of the greatest successes in the history of Naples”. Lo testimoniano le novantasei repliche della prima rappresentazione, avvenuta al Teatro Nuovo di Napoli l’11 luglio 1850, e una fortunata cronologia teatrale durata fino al tardo Ottocento. Don Checco, frutto maturo ed importante del circuito teatrale meridionale in epoca preunitaria ha rivisto le scene allo Showville di Bari lo scorso 15 marzo 2013, in forma di concerto, grazie all’azione congiunta di due specialisti del settore: il M° Angelo Cavallaro, attuale direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, già per un decennio direttore artistico del Teatro “G. B. Pergolesi” di Jesi (per il quale ha promosso numerose prime in epoca moderna di celebri opere dimenticate, come ad esempio Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj), e il M° Lorenzo Fico, musicologo, direttore d’orchestra e filologo, che dell’opera del compositore barese ha curato l’edizione critica e la direzione musicale.
Violetta, ossia La traviata censurata
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Giuseppe Verdi, La traviata, Operisti dell'Ottocento il 23 febbraio 2013
 La traviata è un’opera il cui argomento è scomodo ancora oggi, sia pure in maniera meno dirompente rispetto al XIX secolo: la storia di una prostituta (d’alto rango, certamente, ma sempre prostituta rimaneva) decisa a cambiare vita nell’inutile tentativo di farsi accettare all’interno della società borghese era considerata decisamente immorale e scandalosa. Non stupisce quindi, l’interesse della censura volto a moralizzare e “normalizzare” il soggetto in questione perché, che diamine, a teatro si va per divertirsi e mica ci si diverte se si pensa all’ipocrisia della società di cui si fa orgogliosamente parte. Nello Stato Pontificio, quindi, si diffuse Violetta, ovvero una versione dell’opera che, a partire dal titolo, minimizzava e nascondeva la maggior parte degli aspetti più scandalosi del capolavoro verdiano. La lettura di questo libretto “censurato” è molto interessante e istruttiva per capire quanto l’opera verdiana avesse colpito nel vivo nel denunciare le contraddizioni di una società molto perbenista ma molto spietata nelle sue regole: come già al debutto veneziano l’azione è spostata al ‘700 (nonostante i ritmi ottocenteschi presenti in partitura, per un’analisi dei quali rimando alla lettura di questo libro) specificando, anzi, che l’intera storia si svolge “all’inizio del 1700”, ma non è questa la sola variante presente nella Violetta che, dopo l’allestimento al Teatro Apollo di Roma nella Stagione di Carnevale del 1854, restò la veste con cui La traviata venne conosciuta in molti teatri fino all’Unità. Gli interventi della censura possono essere distinti in tre sottoinsiemi, peraltro strettamente comunicanti tra loro: quelli di matrice religiosa, quelli di matrice sociale e quelli di matrice che potremmo definire “educativa” o morale. Si tratta di sottoinsiemi tutt’altro che ermetici, ma questa schematizzazione consente una maggiore chiarezza nell’elencare le non poche (e non felici, of course) modifiche imposte al libretto.
La traviata è un’opera il cui argomento è scomodo ancora oggi, sia pure in maniera meno dirompente rispetto al XIX secolo: la storia di una prostituta (d’alto rango, certamente, ma sempre prostituta rimaneva) decisa a cambiare vita nell’inutile tentativo di farsi accettare all’interno della società borghese era considerata decisamente immorale e scandalosa. Non stupisce quindi, l’interesse della censura volto a moralizzare e “normalizzare” il soggetto in questione perché, che diamine, a teatro si va per divertirsi e mica ci si diverte se si pensa all’ipocrisia della società di cui si fa orgogliosamente parte. Nello Stato Pontificio, quindi, si diffuse Violetta, ovvero una versione dell’opera che, a partire dal titolo, minimizzava e nascondeva la maggior parte degli aspetti più scandalosi del capolavoro verdiano. La lettura di questo libretto “censurato” è molto interessante e istruttiva per capire quanto l’opera verdiana avesse colpito nel vivo nel denunciare le contraddizioni di una società molto perbenista ma molto spietata nelle sue regole: come già al debutto veneziano l’azione è spostata al ‘700 (nonostante i ritmi ottocenteschi presenti in partitura, per un’analisi dei quali rimando alla lettura di questo libro) specificando, anzi, che l’intera storia si svolge “all’inizio del 1700”, ma non è questa la sola variante presente nella Violetta che, dopo l’allestimento al Teatro Apollo di Roma nella Stagione di Carnevale del 1854, restò la veste con cui La traviata venne conosciuta in molti teatri fino all’Unità. Gli interventi della censura possono essere distinti in tre sottoinsiemi, peraltro strettamente comunicanti tra loro: quelli di matrice religiosa, quelli di matrice sociale e quelli di matrice che potremmo definire “educativa” o morale. Si tratta di sottoinsiemi tutt’altro che ermetici, ma questa schematizzazione consente una maggiore chiarezza nell’elencare le non poche (e non felici, of course) modifiche imposte al libretto.
Alessandro nell’Indie di Giovanni Pacini
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Alessandro nell'Indie, Biblioteca / Discoteca, CD, Giovanni Pacini, Operisti minori dell'Ottocento il 10 novembre 2012
 Quando Giovanni Pacini compone Alessandro nell’Indie è il 1824 e l’opera rappresenta il suo debutto con una nuova composizione nella prestigiosa piazza napoletana, all’epoca metropoli tra le più attive e vivaci per quanto riguarda l’opera lirica. La musica di Pacini era ovviamente nota ai napoletani, che avevano ascoltato alcune delle sue precedenti composizioni sia al San Carlo che al Teatro del Fondo (sembra incredibile ma il nemmeno trentenne compositore, all’epoca, aveva composto più di venti opere, la maggior parte delle quali avevano debuttato a Milano, sia al Teatro Re che alla Scala) ma è con l’Alessandro nell’Indie che il compositore avrebbe fatto ascoltare per la prima volta una musica nuova sul palco che lo avrebbe visto, negli anni seguenti, trionfare prima con L’ultimo giorno di Pompei del 1825 e poi, tanto per citare solo un altro titolo, con la Saffo del 1840, a tutt’oggi l’opera paciniana più giustamente celebre. Alessandro nell’Indie fu un debutto molto sofferto e Pacini stesso ne parla con dovizia di particolari nelle sue Memorie: “Eccoci alla prima sera fatale! Il teatro era affollatissimo poiché trattavasi di dover giudicare un’opera nuova d’un giovane maestro. Rimasi meravigliato (almeno in quell’epoca) del contegno dell’udienza. Si poteva dire di essere veramente ad un teatro di corte. Principia lo spettacolo. Un silenzio perfetto regna durante l’intera esecuzione!… Niuno applauso agli artisti, e per conseguenza neppure al povero maestro. Alla fine dell’opera un mite zi… zi… zi… si ripete in quel vasto recinto. Lascio considerare al lettore lo stato mio! Aveva passato l’intera serata esposto alla berlina (poiché si usava tuttora che l’autore dovesse andare al cembalo altro non facendo che voltare i fogli al violoncello ed al contrabbasso), fra la speranza ed il timore, essendo stato prevenuto che il pubblico di S. Carlo non applaudiva mai alla prima udizione di una nuova musica, ed assicurato che anche il gigante pesarese aveva subito la stessa sorte co’ suoi capi d’opera, principiando dall’Elisabetta. Ma il zittire alla fine dello spettacolo mi spaventò!“
Quando Giovanni Pacini compone Alessandro nell’Indie è il 1824 e l’opera rappresenta il suo debutto con una nuova composizione nella prestigiosa piazza napoletana, all’epoca metropoli tra le più attive e vivaci per quanto riguarda l’opera lirica. La musica di Pacini era ovviamente nota ai napoletani, che avevano ascoltato alcune delle sue precedenti composizioni sia al San Carlo che al Teatro del Fondo (sembra incredibile ma il nemmeno trentenne compositore, all’epoca, aveva composto più di venti opere, la maggior parte delle quali avevano debuttato a Milano, sia al Teatro Re che alla Scala) ma è con l’Alessandro nell’Indie che il compositore avrebbe fatto ascoltare per la prima volta una musica nuova sul palco che lo avrebbe visto, negli anni seguenti, trionfare prima con L’ultimo giorno di Pompei del 1825 e poi, tanto per citare solo un altro titolo, con la Saffo del 1840, a tutt’oggi l’opera paciniana più giustamente celebre. Alessandro nell’Indie fu un debutto molto sofferto e Pacini stesso ne parla con dovizia di particolari nelle sue Memorie: “Eccoci alla prima sera fatale! Il teatro era affollatissimo poiché trattavasi di dover giudicare un’opera nuova d’un giovane maestro. Rimasi meravigliato (almeno in quell’epoca) del contegno dell’udienza. Si poteva dire di essere veramente ad un teatro di corte. Principia lo spettacolo. Un silenzio perfetto regna durante l’intera esecuzione!… Niuno applauso agli artisti, e per conseguenza neppure al povero maestro. Alla fine dell’opera un mite zi… zi… zi… si ripete in quel vasto recinto. Lascio considerare al lettore lo stato mio! Aveva passato l’intera serata esposto alla berlina (poiché si usava tuttora che l’autore dovesse andare al cembalo altro non facendo che voltare i fogli al violoncello ed al contrabbasso), fra la speranza ed il timore, essendo stato prevenuto che il pubblico di S. Carlo non applaudiva mai alla prima udizione di una nuova musica, ed assicurato che anche il gigante pesarese aveva subito la stessa sorte co’ suoi capi d’opera, principiando dall’Elisabetta. Ma il zittire alla fine dello spettacolo mi spaventò!“
Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Giulietta e Romeo, Nicola Vaccaj, Operisti minori dell'Ottocento il 22 settembre 2012
 Esistono casi della vita piuttosto strani, che possono rendere un’opera d’arte celeberrima e misconosciuta al tempo stesso. Un esempio è nel Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj, compositore di Tolentino (Macerata): ogni studente di canto conosce il nome di Vaccaj, in quanto autore di uno dei più apprezzati e celebrati metodi per l’addestramento della voce del XIX secolo, in uso ancora oggi; ogni appassionato belliniano conosce Vaccaj perché dal suo Giulietta e Romeo deriva il libretto (sempre a cura di Felice Romani) dei più celebri (e, onestamente, più riusciti) Capuleti ed i Montecchi di Bellini senza dimenticare che, secondo una pratica cara all’ego delle primedonne ottocentesche, il finale di questa dimenticata opera di Vaccaj veniva quasi sempre inserito nel corpo nell’opera belliniana, perché considerato più efficace, tanto che la Ricordi ufficializzò la pratica pubblicandolo in appendice allo spartito e alle parti dei Capuleti. Solo di recente, e con la nuova edizione critica dell’opera a cura di Claudio Toscani (Milano, Ricordi 2003) si è formalizzato il definitivo abbandono nella pratica teatrale di questa curiosa tradizione. Una tradizione curiosa perché, pur permettendo all’opera di continuare a essere conosciuta e consentendo al nome di Vaccaj di perpetuare la propria fama, di fatto seppellì nell’oblio tutta la musica che precedeva la cosiddetta “scena dei sepolcri”: dopo il debutto al Teatro alla Canobbiana di Milano, avvenuto il 31 ottobre 1825, l’opera aveva infatti conosciuto una relativa diffusione fino al debutto dei Capuleti (Teatro La Fenice di Venezia, 11 marzo 1830) per poi vivacchiare fino alla metà degli anni ’30, dopo un’ultimo allestimento milanese con il Romeo di Maria Malibran in un’edizione, peraltro, ampiamente rimaneggiata (Giulietta fu Sophie Schoberlechner). Solo la scena finale, quindi, sopravvisse, ma dopo nemmeno vent’anni dal debutto il resto dell’opera era già dimenticato. Curioso peraltro che l’ultimo Romeo ottocentesco (famosa interprete, anche se in non molte produzioni, dell’altra celebre opera di Nicola Antonio Zingarelli sul medesimo soggetto) sia stata proprio l’artista spagnola al cui nome è legato il capriccio della sostituzione del finale di Bellini con quello di Vaccaj (ma vedremo che non fu la Malibran la prima a imporre la sostituzione).
Esistono casi della vita piuttosto strani, che possono rendere un’opera d’arte celeberrima e misconosciuta al tempo stesso. Un esempio è nel Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj, compositore di Tolentino (Macerata): ogni studente di canto conosce il nome di Vaccaj, in quanto autore di uno dei più apprezzati e celebrati metodi per l’addestramento della voce del XIX secolo, in uso ancora oggi; ogni appassionato belliniano conosce Vaccaj perché dal suo Giulietta e Romeo deriva il libretto (sempre a cura di Felice Romani) dei più celebri (e, onestamente, più riusciti) Capuleti ed i Montecchi di Bellini senza dimenticare che, secondo una pratica cara all’ego delle primedonne ottocentesche, il finale di questa dimenticata opera di Vaccaj veniva quasi sempre inserito nel corpo nell’opera belliniana, perché considerato più efficace, tanto che la Ricordi ufficializzò la pratica pubblicandolo in appendice allo spartito e alle parti dei Capuleti. Solo di recente, e con la nuova edizione critica dell’opera a cura di Claudio Toscani (Milano, Ricordi 2003) si è formalizzato il definitivo abbandono nella pratica teatrale di questa curiosa tradizione. Una tradizione curiosa perché, pur permettendo all’opera di continuare a essere conosciuta e consentendo al nome di Vaccaj di perpetuare la propria fama, di fatto seppellì nell’oblio tutta la musica che precedeva la cosiddetta “scena dei sepolcri”: dopo il debutto al Teatro alla Canobbiana di Milano, avvenuto il 31 ottobre 1825, l’opera aveva infatti conosciuto una relativa diffusione fino al debutto dei Capuleti (Teatro La Fenice di Venezia, 11 marzo 1830) per poi vivacchiare fino alla metà degli anni ’30, dopo un’ultimo allestimento milanese con il Romeo di Maria Malibran in un’edizione, peraltro, ampiamente rimaneggiata (Giulietta fu Sophie Schoberlechner). Solo la scena finale, quindi, sopravvisse, ma dopo nemmeno vent’anni dal debutto il resto dell’opera era già dimenticato. Curioso peraltro che l’ultimo Romeo ottocentesco (famosa interprete, anche se in non molte produzioni, dell’altra celebre opera di Nicola Antonio Zingarelli sul medesimo soggetto) sia stata proprio l’artista spagnola al cui nome è legato il capriccio della sostituzione del finale di Bellini con quello di Vaccaj (ma vedremo che non fu la Malibran la prima a imporre la sostituzione).
Teseo riconosciuto di Gaspare Spontini
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Gaspare Spontini, Operisti in Europa, Teseo riconosciuto il 8 settembre 2012
![]() La riscoperta della Civiltà Musicale Marchigiana – Questo progetto del Teatro Pergolesi di Jesi, gestito dal 1995 al 2003 dall’allora direttore artistico Angelo Cavallaro, previde la prima esecuzione moderna di opere assai rare (delle quali, quando necessario, venne effettuata la revisione critica) di autori marchigiani: in tutto vennero eseguite otto opere, sei delle quali legate al repertorio dell’Ottocento Italiano. Partendo dal ricordo di quelle riproposte jesine (la maggior parte delle quali è stata documentata in cd Bongiovanni) la rubrica Musica di Marca intende racchiudere tutti i post dedicati ai compositori minori marchigiani del XIX secolo (quali Alessandro Nini, Giuseppe Persiani, Lauro Rossi o Nicola Vaccaj) assieme ai post dedicati a Gaspare Spontini, che minore non fu ma appare nondimeno poco considerato, anche se ingiustamente, nei cartelloni attuali. Resta escluso dalla rubrica, per ovvie ragioni avendo una categoria a parte, il pesarese per eccellenza, Gioachino Rossini. Le opere alla base del progetto della riscoperta della Civiltà Musicale Marchigiana saranno i punti di partenza di una rubrica che si propone di valorizzare (nei limiti della diffusione del presente blog) quei lavori minori assimilabili allo stile dell’Ottocento italiano o che, come è il caso del Teseo riconosciuto, ne anticipano in parte alcune inquietudini.
La riscoperta della Civiltà Musicale Marchigiana – Questo progetto del Teatro Pergolesi di Jesi, gestito dal 1995 al 2003 dall’allora direttore artistico Angelo Cavallaro, previde la prima esecuzione moderna di opere assai rare (delle quali, quando necessario, venne effettuata la revisione critica) di autori marchigiani: in tutto vennero eseguite otto opere, sei delle quali legate al repertorio dell’Ottocento Italiano. Partendo dal ricordo di quelle riproposte jesine (la maggior parte delle quali è stata documentata in cd Bongiovanni) la rubrica Musica di Marca intende racchiudere tutti i post dedicati ai compositori minori marchigiani del XIX secolo (quali Alessandro Nini, Giuseppe Persiani, Lauro Rossi o Nicola Vaccaj) assieme ai post dedicati a Gaspare Spontini, che minore non fu ma appare nondimeno poco considerato, anche se ingiustamente, nei cartelloni attuali. Resta escluso dalla rubrica, per ovvie ragioni avendo una categoria a parte, il pesarese per eccellenza, Gioachino Rossini. Le opere alla base del progetto della riscoperta della Civiltà Musicale Marchigiana saranno i punti di partenza di una rubrica che si propone di valorizzare (nei limiti della diffusione del presente blog) quei lavori minori assimilabili allo stile dell’Ottocento italiano o che, come è il caso del Teseo riconosciuto, ne anticipano in parte alcune inquietudini.
acta est fabula – 5 – Jone, o L’ultimo giorno di Pompei di Errico Petrella
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Errico Petrella, Jone, o L'ultimo giorno di Pompei, Operisti minori dell'Ottocento il 4 agosto 2012
 Parlare di atmosfere tardo ottocentesche già nel 1858 è, forse, un azzardo, ma è in questa data che, con Jone, o L’ultimo giorno di Pompei, su libretto di Giovanni Peruzzini, il compositore palermitano Errico Petrella (1813 – 1877) introduce nel mondo dell’opera lirica una serie di topoi che diventeranno sempre più diffusi man mano che il XIX secolo si avvierà verso la conclusione: si parte dalla definizione quotidiana del mondo pagano come luogo di lussuria e di piaceri smodati (li potremmo già chiamare decadenti) così come si vede nella taverna che ci appare al I Atto, in cui gladiatori e giovani patrizi giocano e bevono ad “alba già inoltrata” e si prosegue con la vivace e popolaresca raffigurazione del mercato di Pompei alla sera, che anticipa tutte le scene “pittoresche” di cui sarà prodiga l’opera verista (anche nel testo: “Chi vuol pistacchi e datteri!… / aranci ne vuole!… / Garofani, viole, / rose, chi vuol comprar. / D’ogni gusto, d’ogni odor, / qui son frutta, qui son fior. / Murene di vivaio, / ostriche di scogliera! / Tarda si fa la sera… / presto,… chi vuol comprar. / N’ho di lago, n’ho di mar… / Chi il mio pesce vuol comprar!”). Il libretto di Peruzzini, a differenza della quasi omonima opera di Giovanni Pacini, è tratto dal romanzo The Last Days of Pompeii dello scrittore britannico Edward Bulwer-Lytton, da cui l’autore elimina la conversione al cristianesimo dei protagonisti dando invece spazio alla ricreazione un po’ macchiettistica della vita quotidiana dell’epoca: come nota lo studioso Luigi Baldacci “se il mondo dell’opera aveva fatto uso ed abuso di una romanità di stampo metastasiano incentrata sul dovere, l’onore, l’amore della patria e il culto degli dei, la Pompei del Peruzzini ci fa conoscere la ROMA-AMOR“; una “ROMA-AMOR” (aggiungo io) non priva di velleità archeologico-storiche mutuate da Bulwer-Lytton, come quando si fa un preciso riferimento al violento terremoto che interessò la Campania nel 63 d.C (precedente la disastrosa eruzione del 79 d.C che distrusse Pompei) facendo cantare al coro, nella stessa scena del mercato di cui sopra: “Come l’aria sa di zolfo!… / È presagio di sventura. / par che s’alzi là dal golfo / una nebbia scura, scura. / Da tre giorni, o molto, o poco, / il Vesuvio manda foco… / Sedici anni restò zitto… / che si desti è da temer.”
Parlare di atmosfere tardo ottocentesche già nel 1858 è, forse, un azzardo, ma è in questa data che, con Jone, o L’ultimo giorno di Pompei, su libretto di Giovanni Peruzzini, il compositore palermitano Errico Petrella (1813 – 1877) introduce nel mondo dell’opera lirica una serie di topoi che diventeranno sempre più diffusi man mano che il XIX secolo si avvierà verso la conclusione: si parte dalla definizione quotidiana del mondo pagano come luogo di lussuria e di piaceri smodati (li potremmo già chiamare decadenti) così come si vede nella taverna che ci appare al I Atto, in cui gladiatori e giovani patrizi giocano e bevono ad “alba già inoltrata” e si prosegue con la vivace e popolaresca raffigurazione del mercato di Pompei alla sera, che anticipa tutte le scene “pittoresche” di cui sarà prodiga l’opera verista (anche nel testo: “Chi vuol pistacchi e datteri!… / aranci ne vuole!… / Garofani, viole, / rose, chi vuol comprar. / D’ogni gusto, d’ogni odor, / qui son frutta, qui son fior. / Murene di vivaio, / ostriche di scogliera! / Tarda si fa la sera… / presto,… chi vuol comprar. / N’ho di lago, n’ho di mar… / Chi il mio pesce vuol comprar!”). Il libretto di Peruzzini, a differenza della quasi omonima opera di Giovanni Pacini, è tratto dal romanzo The Last Days of Pompeii dello scrittore britannico Edward Bulwer-Lytton, da cui l’autore elimina la conversione al cristianesimo dei protagonisti dando invece spazio alla ricreazione un po’ macchiettistica della vita quotidiana dell’epoca: come nota lo studioso Luigi Baldacci “se il mondo dell’opera aveva fatto uso ed abuso di una romanità di stampo metastasiano incentrata sul dovere, l’onore, l’amore della patria e il culto degli dei, la Pompei del Peruzzini ci fa conoscere la ROMA-AMOR“; una “ROMA-AMOR” (aggiungo io) non priva di velleità archeologico-storiche mutuate da Bulwer-Lytton, come quando si fa un preciso riferimento al violento terremoto che interessò la Campania nel 63 d.C (precedente la disastrosa eruzione del 79 d.C che distrusse Pompei) facendo cantare al coro, nella stessa scena del mercato di cui sopra: “Come l’aria sa di zolfo!… / È presagio di sventura. / par che s’alzi là dal golfo / una nebbia scura, scura. / Da tre giorni, o molto, o poco, / il Vesuvio manda foco… / Sedici anni restò zitto… / che si desti è da temer.”
acta est fabula – 4 – La Vestale di Saverio Mercadante
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, La vestale, Operisti minori dell'Ottocento, Saverio Mercadante il 28 luglio 2012
 Il soggetto della spontiniana Vestale (opera del 1807 in cui il conflitto tra l’amore e la religione viene felicimente risolto con il perdono divino del finale e relativo, festoso, matrimonio dei due protagonisti) non era nuovo nei primi decenni dell’800 e conservò una sua popolarità almeno fino alla metà del XIX secolo: prima di Gaspare Spontini musicarono un soggetto simile anche Domenico Cimarosa, Giuseppe Sarti, Giacomo Tritto, mentre dopo Spontini esso fu affrontato anche da Vincenzo Pucitta, Giovanni Pacini e, soprattutto, Saverio Mercadante, la cui Vestale (debutto al Teatro San Carlo di Napoli il 10 marzo 1840) appare particolarmente interessante per come vira in atmosfere tragiche e disperate (in una parola: romantiche) l’ottimismo “neoclassico” che, a dispetto del conflitto tra religione e amore, permea il capolavoro di Spontini, rendendolo una storia densa di cupo e desolante “male di vivere”, sullo sfondo di una Roma fastosa e opprimente, già decadente perché troppo sontuosa e con i germi del declino ravvisabili nel meccanismo che sovrintende a esistenze votate al culto di dei lontani, irraggiungibili e indifferenti, da placare con inumani e inutili sacrifici. Se si dovesse fare un paragone con un’opera d’arte dei nostri tempi si potrebbe paragonare, mutatis mutandis, l’atmosfera rinunciataria e cupa di questa opera mercadantiana a quella, pure desolante e priva di speranza, del romanzo La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano.
Il soggetto della spontiniana Vestale (opera del 1807 in cui il conflitto tra l’amore e la religione viene felicimente risolto con il perdono divino del finale e relativo, festoso, matrimonio dei due protagonisti) non era nuovo nei primi decenni dell’800 e conservò una sua popolarità almeno fino alla metà del XIX secolo: prima di Gaspare Spontini musicarono un soggetto simile anche Domenico Cimarosa, Giuseppe Sarti, Giacomo Tritto, mentre dopo Spontini esso fu affrontato anche da Vincenzo Pucitta, Giovanni Pacini e, soprattutto, Saverio Mercadante, la cui Vestale (debutto al Teatro San Carlo di Napoli il 10 marzo 1840) appare particolarmente interessante per come vira in atmosfere tragiche e disperate (in una parola: romantiche) l’ottimismo “neoclassico” che, a dispetto del conflitto tra religione e amore, permea il capolavoro di Spontini, rendendolo una storia densa di cupo e desolante “male di vivere”, sullo sfondo di una Roma fastosa e opprimente, già decadente perché troppo sontuosa e con i germi del declino ravvisabili nel meccanismo che sovrintende a esistenze votate al culto di dei lontani, irraggiungibili e indifferenti, da placare con inumani e inutili sacrifici. Se si dovesse fare un paragone con un’opera d’arte dei nostri tempi si potrebbe paragonare, mutatis mutandis, l’atmosfera rinunciataria e cupa di questa opera mercadantiana a quella, pure desolante e priva di speranza, del romanzo La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano.
acta est fabula – 3 – L’esule di Roma di Gaetano Donizetti
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Gaetano Donizetti, L'esule di Roma, Operisti dell'Ottocento il 14 luglio 2012
 L’epistolario di Gaetano Donizetti è uno dei testi più affascinanti, per un musicofilo, lasciati da un compositore ottocentesco: esso ci rivela non solo moltissime informazioni sulla vita quotidiana dei teatri del tempo, ma anche la descrizione di un uomo buono, onesto, dalle ottime capacità letterarie e consapevole delle sue qualità e delle sue potenzialità. Dopo il debutto del suo esule di Roma (Teatro San Carlo di Napoli, 1 gennaio 1828) troviamo una lettera particolarmente interessante sulla poetica e le ambizioni donizettiane (ricordo che il compositore, al momento di scrivere la lettera destinata al suo Maestro Mayr, non aveva ancora scritto nessuna opera con finale tragico, con l’ovvia esclusione della Gabriella di Vergy che, però, non era mai stata messa in scena):
L’epistolario di Gaetano Donizetti è uno dei testi più affascinanti, per un musicofilo, lasciati da un compositore ottocentesco: esso ci rivela non solo moltissime informazioni sulla vita quotidiana dei teatri del tempo, ma anche la descrizione di un uomo buono, onesto, dalle ottime capacità letterarie e consapevole delle sue qualità e delle sue potenzialità. Dopo il debutto del suo esule di Roma (Teatro San Carlo di Napoli, 1 gennaio 1828) troviamo una lettera particolarmente interessante sulla poetica e le ambizioni donizettiane (ricordo che il compositore, al momento di scrivere la lettera destinata al suo Maestro Mayr, non aveva ancora scritto nessuna opera con finale tragico, con l’ovvia esclusione della Gabriella di Vergy che, però, non era mai stata messa in scena):
L’anno venturo finirò il primo atto con un quartetto ed il secondo con una morte a mio modo. Voglio scuotere il giogo dei finali… ma per adesso finire a terzetto mai più, poiché tutti mi dicono, che se morissi […] e rinascessi non farei più cosa simile… ma io incoraggio, mi sento capace di fare cose migliori.
L’esule di Roma ci colpisce perché, oltre a essere la prima opera donizettiana di ambientazione neoclassica, è una testimonianza di come l’opera neoclassica fosse divenuta anche terreno fertile per le sperimentazioni, in questo caso innestando all’interno della composizione un triangolo praticamente borghese, in cui l’ambientazione romana è di fatto un pretesto per l’esplorazione dei caratteri psicologici dei tre protagonisti (il terzetto che chiude il I Atto, cui Donizetti allude nella lettera). La grandiosità delle chiusure d’atto di Ecuba e dell’ultimo giorno di Pompei appare lontana dall’intimo clima di scontro familiare di questo terzetto, che costiuisce l’intero blocco del Finale I e che fu tra i brani più celebri (ai suoi dì) dell’opera in questione.
acta est fabula – 2 – L’ultimo giorno di Pompei di Giovanni Pacini
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Giovanni Pacini, L'ultimo giorno di Pompei, Operisti minori dell'Ottocento il 7 luglio 2012
 La riscoperta dei resti della città di Pompei (iniziata con i primi scavi del 1738) conobbe un relativo momento di vivacità dal 1808, quando la moglie di Gioacchino Murat, Carolina Bonaparte, incoraggiò e potenziò le operazioni di scavo delle città sepolte dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. È in questo clima (da notare che anche i Borboni, sia pur in misura minore, contribuirono agli scavi di Pompei negli anni ’20 e ’30 del XIX secolo) che il Teatro San Carlo ospita, il 19 novembre 1825, il debutto de L’ultimo giorno di Pompei di Giovanni Pacini, interessante opera kolossal – catastrofica che, anche grazie alle maestose scenografie di Alessandro Sanquirico, stupì il pubblico napoletano cogliendo un deciso successo. Il gusto per lo spettacolare effetto scenico, mutuato in parte dall’opera francese, si univa a un’ambientazione neoclassica calata in un’atmosfera apocalittica (già dal titolo) nella cui incombente tragicità non è peregrino cogliere già un aspetto romantico: l’opera precede di nove anni il poi celeberrimo romanzo The Last Days of Pompeii dello scrittore britannico Edward Bulwer-Lytton, la cui trama sarà alla base di buona parte delle successive manifestazioni artistiche ispirate agli ultimi momenti di Pompei. Nell’opera di Pacini il gusto per il pittoresco e per la ricostruzione pompeiana (evidente nella cura delle didascalie del libretto di Andrea Leone Tottola) si unisce all’impianto dell’opera neoclassica mutuata dallo stile francese, creando un melodramma decisamente diverso dalle opere composte a inizio secolo; lo stacco rispetto a un capolavoro come l’Ecuba è radicale, dato che gli influssi rossiniani sono ingombranti e presenti, nonostante la presenza di una costruzione drammaturgica discretamente originale in alcune scene: il risultato è un’opera abbastanza vivace, un mélange di suggestioni e spunti culturali che, nella sua eterogeneità, non sembra privo di fascino ed efficacia.
La riscoperta dei resti della città di Pompei (iniziata con i primi scavi del 1738) conobbe un relativo momento di vivacità dal 1808, quando la moglie di Gioacchino Murat, Carolina Bonaparte, incoraggiò e potenziò le operazioni di scavo delle città sepolte dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. È in questo clima (da notare che anche i Borboni, sia pur in misura minore, contribuirono agli scavi di Pompei negli anni ’20 e ’30 del XIX secolo) che il Teatro San Carlo ospita, il 19 novembre 1825, il debutto de L’ultimo giorno di Pompei di Giovanni Pacini, interessante opera kolossal – catastrofica che, anche grazie alle maestose scenografie di Alessandro Sanquirico, stupì il pubblico napoletano cogliendo un deciso successo. Il gusto per lo spettacolare effetto scenico, mutuato in parte dall’opera francese, si univa a un’ambientazione neoclassica calata in un’atmosfera apocalittica (già dal titolo) nella cui incombente tragicità non è peregrino cogliere già un aspetto romantico: l’opera precede di nove anni il poi celeberrimo romanzo The Last Days of Pompeii dello scrittore britannico Edward Bulwer-Lytton, la cui trama sarà alla base di buona parte delle successive manifestazioni artistiche ispirate agli ultimi momenti di Pompei. Nell’opera di Pacini il gusto per il pittoresco e per la ricostruzione pompeiana (evidente nella cura delle didascalie del libretto di Andrea Leone Tottola) si unisce all’impianto dell’opera neoclassica mutuata dallo stile francese, creando un melodramma decisamente diverso dalle opere composte a inizio secolo; lo stacco rispetto a un capolavoro come l’Ecuba è radicale, dato che gli influssi rossiniani sono ingombranti e presenti, nonostante la presenza di una costruzione drammaturgica discretamente originale in alcune scene: il risultato è un’opera abbastanza vivace, un mélange di suggestioni e spunti culturali che, nella sua eterogeneità, non sembra privo di fascino ed efficacia.
acta est fabula – 1 – Ecuba di Nicola Antonio Manfroce
Pubblicato da Gabriele Cesaretti in Biblioteca / Discoteca, CD, Ecuba, Nicola Antonio Manfroce, Operisti minori dell'Ottocento il 30 giugno 2012
 Spesso, in occasione di discutibili riscoperte di titoli minori (anche nel caso di autori celeberrimi) si sente gridare al capolavoro ritrovato, questo nonostante siano pochissimi i casi in cui un vero capolavoro viene recuperato grazie a queste “riesumazioni” (come macabramente spesso vengono chiamate). Una luminosa eccezione è però costituita da Nicola Antonio Manfroce (1791-1813), compositore calabrese che nell’arco di una vita brevissima (appena 22 anni) riuscì a far allestire un’opera del massimo interesse come Ecuba, con cui colse un lusinghiero successo grazie alla potenza di una partitura in cui si coniugano l’impressione ricevuta dalla tragédie lyrique francese e la gloriosa tradizione dell’opera partenopea. Dopo aver composto nel 1809 la cantata La nascita di Alcide e dopo aver presentato nel 1810 un’Alzira su teso di Gaetano Rossi al Teatro Valle di Roma con le celebri Isabella Colbran e Adelaide Malanotte, Manfroce venne infatti scritturato dall’impresario Domenico Barbaja per un nuovo spartito che avrebbe debuttato al Teatro San Carlo di Napoli nel 1812: il 13 dicembre l’Ecuba sarebbe andata in scena con un cast d’eccezione formato da Maria Marchesini e Marianna Borroni (rispettivamente Ecuba e Polissena) oltre che dai celebri Manuel García (Achille) e Andrea Nozzari (Priamo).
Spesso, in occasione di discutibili riscoperte di titoli minori (anche nel caso di autori celeberrimi) si sente gridare al capolavoro ritrovato, questo nonostante siano pochissimi i casi in cui un vero capolavoro viene recuperato grazie a queste “riesumazioni” (come macabramente spesso vengono chiamate). Una luminosa eccezione è però costituita da Nicola Antonio Manfroce (1791-1813), compositore calabrese che nell’arco di una vita brevissima (appena 22 anni) riuscì a far allestire un’opera del massimo interesse come Ecuba, con cui colse un lusinghiero successo grazie alla potenza di una partitura in cui si coniugano l’impressione ricevuta dalla tragédie lyrique francese e la gloriosa tradizione dell’opera partenopea. Dopo aver composto nel 1809 la cantata La nascita di Alcide e dopo aver presentato nel 1810 un’Alzira su teso di Gaetano Rossi al Teatro Valle di Roma con le celebri Isabella Colbran e Adelaide Malanotte, Manfroce venne infatti scritturato dall’impresario Domenico Barbaja per un nuovo spartito che avrebbe debuttato al Teatro San Carlo di Napoli nel 1812: il 13 dicembre l’Ecuba sarebbe andata in scena con un cast d’eccezione formato da Maria Marchesini e Marianna Borroni (rispettivamente Ecuba e Polissena) oltre che dai celebri Manuel García (Achille) e Andrea Nozzari (Priamo).
















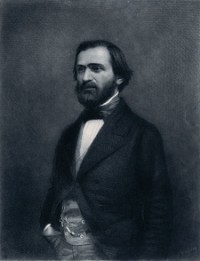





Commenti recenti