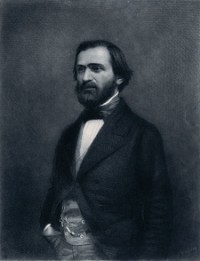L’ingresso del concetto di regia nel mondo dell’opera lirica è avvenuto ormai da molti anni ma, che ci si creda o meno, è ancora visto con sospetto dal mondo melomane. Tra le ragioni di questa diffidenza c’è il madornale equivoco che ancora, almeno in Italia, tende a confondere il concetto di regia (ovvero il lavoro con gli artisti sui personaggi e sulla recitazione) con l’ambientazione scenografica. Basta, quindi, un’ambientazione che non sia rispettosa dei dettami librettistici per parlare di avanguardia, anche nel caso di una regia tradizionale (rispettosa, quindi dei rapporti tra i personaggi e, in generale, della trama), mentre una regia radicalmente ripensata e decontestualizzata, magari calata in un’ambientazione storica e rassicurante, tende a passare inosservata. Il mondo della prosa ha superato questa impasse ormai da molti anni, mentre nel mondo dell’opera ancora si fa molta fatica a distinguere il grano dal loglio (un’ambientazione contemporanea o infedele al libretto NON è sempre sinonimo di grande interpretazione) nell’ambito delle proposte più stimolanti e ripensate.
L’ingresso del concetto di regia nel mondo dell’opera lirica è avvenuto ormai da molti anni ma, che ci si creda o meno, è ancora visto con sospetto dal mondo melomane. Tra le ragioni di questa diffidenza c’è il madornale equivoco che ancora, almeno in Italia, tende a confondere il concetto di regia (ovvero il lavoro con gli artisti sui personaggi e sulla recitazione) con l’ambientazione scenografica. Basta, quindi, un’ambientazione che non sia rispettosa dei dettami librettistici per parlare di avanguardia, anche nel caso di una regia tradizionale (rispettosa, quindi dei rapporti tra i personaggi e, in generale, della trama), mentre una regia radicalmente ripensata e decontestualizzata, magari calata in un’ambientazione storica e rassicurante, tende a passare inosservata. Il mondo della prosa ha superato questa impasse ormai da molti anni, mentre nel mondo dell’opera ancora si fa molta fatica a distinguere il grano dal loglio (un’ambientazione contemporanea o infedele al libretto NON è sempre sinonimo di grande interpretazione) nell’ambito delle proposte più stimolanti e ripensate.
Un esempio di spettacolo decontestualizzato e ripensato, sia dal punto di vista registico che dell’ambientazione, ma al tempo stesso sostanzialmente fedele in molti punti agli equilibri del libretto originale, è stato offerto dalla recente produzione dei verdiani Vespri Siciliani che il Teatro Regio di Torino ha allestito nell’ambito delle Celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia.
Davide Livermore, al timone della regia, ha scelto di spostare nel tempo la vicenda dell’opera, calandola nella nostra contemporaneità e parlando un linguaggio ricco di riferimenti al presente.
Nessuna fedeltà alla “forma”, per così dire, del libretto verdiano, ma invece un’estrema fedeltà alla sua sostanza e, per quel che mi riguarda, uno degli spettacoli più emozionanti e suggestivi degli ultimi anni, tanto che ben più del Nabucco romano avrebbe meritato una diretta su Rai3 anziché essere relegato, si fa per dire, su Rai Storia, dove inevitabilmente ha ottenuto meno visibilità.
 L’opera di Verdi è estremamente ambigua nella definizione dei caratteri e della personalità dei suoi protagonisti: sappiamo che nel 1282 avvenne, in Sicilia, una rivolta popolare (detta “del Vespro”), sfociata in una guerra conclusasi con l’espulsione dei francesi dall’isola. Che Giovanni Da Procida (personaggio, in ogni caso, realmente esistito) abbia realmente partecipato come organizzatore alla guerra del Vespro è, invece, una leggenda, come già nel 1846 dimostrò lo storico ottocentesco Michele Amari nel suo La Guerra del Vespro Siciliano.
L’opera di Verdi è estremamente ambigua nella definizione dei caratteri e della personalità dei suoi protagonisti: sappiamo che nel 1282 avvenne, in Sicilia, una rivolta popolare (detta “del Vespro”), sfociata in una guerra conclusasi con l’espulsione dei francesi dall’isola. Che Giovanni Da Procida (personaggio, in ogni caso, realmente esistito) abbia realmente partecipato come organizzatore alla guerra del Vespro è, invece, una leggenda, come già nel 1846 dimostrò lo storico ottocentesco Michele Amari nel suo La Guerra del Vespro Siciliano.
Sicuramente stimolato dai forti contrasti affettivi che aveva ammirato nel libretto de Le Prophète di Scribe musicato da Meyerbeer, Verdi chiese al drammaturgo francese un testo che avesse le stesse potenzialità, anche se poi mostrò alcune riserve circa la luce non proprio esemplare in cui erano messi i rivoltosi siciliani.
Confidavo nel fatto che Scribe […] avrebbe cambiato tutto quello che offende l’onore degli italiani. Più rifletto su questo soggetto, più mi convinco che è pericoloso. […] Nella storia di ogni popolo ci sono virtù e crimini, e noi non siamo peggio degli altri.
 Tuttavia furono proprio le ambiguità morali (peraltro presenti anche nel Prophète) dei personaggi e la loro condotta privata a condurre Verdi a una delle sue opere più affascinanti, tanto più toccante perché quasi priva di retorica e, anzi, a posteriori sorprendentemente profetica nel toccare il nervo scoperto delle contraddizioni del Risorgimento. Da questo materiale (la trama dell’opera è reperibile in moltissimi siti ed evito di riproporla) Livermore trae uno spettacolo di grande forza, partendo da alcuni semplici assunti:
Tuttavia furono proprio le ambiguità morali (peraltro presenti anche nel Prophète) dei personaggi e la loro condotta privata a condurre Verdi a una delle sue opere più affascinanti, tanto più toccante perché quasi priva di retorica e, anzi, a posteriori sorprendentemente profetica nel toccare il nervo scoperto delle contraddizioni del Risorgimento. Da questo materiale (la trama dell’opera è reperibile in moltissimi siti ed evito di riproporla) Livermore trae uno spettacolo di grande forza, partendo da alcuni semplici assunti:
- L’individuazione del nemico. Lo stesso Livermore dichiara in un’intervista: “Oggi, in Italia, non abbiamo un invasore straniero. E allora chi, o cosa va a inibire profondamente il senso di partecipazione democratica, di libertà, di condivisione di ideali che, in qualche modo possono portare speranza in una società?” La risposta è nel “fascismo televisivo” che già aveva teorizzato Pasolini, quella dittatura “affascinante” (Parole di Pasolini) che si concretizza nell’imposizione di nuovi bisogni e di “un nuovo fascismo: il potere dei consumi […] che si esprime attraverso la televisione” (Parole sempre di Pasolini);
- Va da sé che la responsabilità di una simile dittatura mediatica sia di chi la propugna e di chi la accetta. Dice Livermore che “una parte di popolazione sarà senza faccia, con facce di gomme: la dignità sarà tolta cancellando loro i lineamenti del viso”.
 Media, politica e, inevitabilmente, mafia: la connivenza di questi tre poteri emerge con grande evidenza, tanto che non mi sento di condividere le riserve di chi rimprovera allo spettacolo di mettere troppa carne al fuoco. Non è Livermore a mettere carne al fuoco, ma è la stessa realtà in cui viviamo a unire strettamente questi aspetti del quotidiano.
Media, politica e, inevitabilmente, mafia: la connivenza di questi tre poteri emerge con grande evidenza, tanto che non mi sento di condividere le riserve di chi rimprovera allo spettacolo di mettere troppa carne al fuoco. Non è Livermore a mettere carne al fuoco, ma è la stessa realtà in cui viviamo a unire strettamente questi aspetti del quotidiano.
La linea del fascismo mediatico appare chiarissima dal I Atto: il funerale di Federico d’Austria, fratello di Elena, ci appare come un imponente funerale di Stato, trasmesso in diretta televisiva. Le battute dei poliziotti collusi col potere sono sapientemente divise tra quello da dire davanti alle telecamere e quello che viene sussurrato a microfoni spenti. La bara è al centro del palcoscenico ed Elena canta il suo dolore nell’immobilità generale, mentre si crea un improvviso fermo immagine su di lei che abbraccia il feretro. L’invito a cantare dei francesi è un invito a parlare al microfono, un invito, quindi, a divenire parte di quello stesso fascimo mediatico e culturale aspettandosi, magari, una giusta dose di pianto (l’audience…) e un ringraziamento ai servitori dello Stato. Quando Elena si lancia invece nel suo canto di rivolta il prete, che le suggeriva cosa dire, le toglie il microfono con un gesto che ci appare come di estrema violenza. Il riferimento, ovviamente, è all’imbarazzante comportamento tenuto nei confronti della vedova Rosaria Schifani durante i funerali di Falcone in diretta televisiva.
 La diretta viene subito bloccata, la folla ostenta le prime pagine dei quotidiani che recitano “Ammazzato” mentre Elena, significativamente, rivolge al prete il suo “Al Ciel fa grave offesa chi manca di coraggio”; sembra l’inizio di una rivolta, ma l’arrivo di Monforte blocca tutto e la gente ha paura: che cosa ci sia di diverso rispetto alla sostanza del libretto originale verdiano davvero non arrivo a capirlo.
La diretta viene subito bloccata, la folla ostenta le prime pagine dei quotidiani che recitano “Ammazzato” mentre Elena, significativamente, rivolge al prete il suo “Al Ciel fa grave offesa chi manca di coraggio”; sembra l’inizio di una rivolta, ma l’arrivo di Monforte blocca tutto e la gente ha paura: che cosa ci sia di diverso rispetto alla sostanza del libretto originale verdiano davvero non arrivo a capirlo.
Il fascismo mediatico della tv ritornerà nella scena del matrimonio delle giovani coppie al II Atto, quando il popolo in festa si muoverà come una selva di marionette impazzite, automi vuoti il cui ballare e gettare rifiuti tra le macchine carbonizzate della Strage di Capaci (mentre i televisori appaiono e si riempiono di nulla) diventa l’agghiacciante ritratto di un paese che rinuncia alla propria civiltà e alla propria memoria per rifugiarsi in una consolante assenza di pensiero. Eppure il canto di Procida a Palermo, le sue parole commosse (“Alza la fronte tanto oltraggiata, il tuo ripiglia primier splendor!”) davanti al disastro delle macchine carbonizzate erano state, poco prima, un emozionante omaggio al senso di civiltà e di patriottismo (il patriottismo vero, non quello viziato da rigurgiti xenofobi) racchiuso nella musica verdiana: quelle auto carbonizzate, apparse dal buio come una sorta di sacro e immobile luogo della memoria, vengono oltraggiate non solo da chi le ha fatte saltare in aria, ma anche di chi non accetta di prendere consapevolezza che sta a lui iniziare il lento processo che porterà al cambiamento.
Parallela all’emozione dell’aria di Procida è quella sviluppata nell’ampio concertato che chiude l’Atto III: le “Splendide Feste” sono un esclusivo party in Parlamento e, al momento del grande assieme finale, sugli schermi iniziano a scorrere immagini della Storia d’Italia, in una carrellata che miracolosamente riesce a evitare il rischio della retorica per colorarsi di sincera commozione.
 Il IV Atto è anche quello in un certo senso più “privato” che, superficialmente, potrebbe apparire anche come quello meno significativo, ma è vero il contrario: già nel I Atto avevamo visto l’identità che si era creata tra la collusione criminale del potere e chi gestiva il potere stesso (ovvero Monforte, che entra, al termine del duetto con Arrigo, nel palazzo davanti a cui ha avuto luogo la diretta solenne dei Funerali di Stato e in cui si troverà per la sua “In braccio alle dovizie”) e questa identità viene rafforzata dalla visione dell’esecuzione. Essendo il party parlamentare un party privato la notizia dell’attentato non è, evidentemente, nota alla stampa: Elena e Procida sono così prigionieri all’interno dello stesso palazzo governativo e stanno per essere giustiziati senza troppi clamori facendo poi, presumibilmente, scomparire i loro cadaveri. Monforte sovrintende all’esecuzione privata con freddezza e ci appare evidente che non deve essere la prima a cui assiste: per lui si tratta, in fondo, di un ennesimo regolamento di conti al di fuori delle regole della Giustizia. Quando Arrigo accetterà di chiamare “Padre” Monforte la scena, di colpo, diventa quella di una diretta televisiva, con Monforte che, magari a rete unificate, da alla nazione l’annuncio della riscoperta di suo figlio e delle sue imminenti nozze, salutate da un vacuo giubilo generale. Il violento e brusco passaggio che Verdi compie dal “privato” al “pubblico” in questo Finale IV (ovvero dall’imminente esecuzione alla festa popolare) viene reso con una forza pari solo al disagio che, da spettatori, sentiamo nell’evidente ambiguità morale che si è creata a questo punto dell’opera: il “buono”, Arrigo, si è piegato ai voleri del “cattivo”, Monforte (che però magari così cattivo non è), mentre Procida, presentatoci come patriota commosso, rivela un suo lato oscuro e spietato. Tutto questo non emerge dalla regia di Livermore, beninteso, ma dalla stessa opera verdiana: Livermore non fa che esternarlo con un linguaggio in grado di parlare al pubblico contemporaneo. Palese e significativo, in questo contesto, il disagio di Elena, da ribelle divenuta nuora del tiranno e come tale presentata alla folla osannante.
Il IV Atto è anche quello in un certo senso più “privato” che, superficialmente, potrebbe apparire anche come quello meno significativo, ma è vero il contrario: già nel I Atto avevamo visto l’identità che si era creata tra la collusione criminale del potere e chi gestiva il potere stesso (ovvero Monforte, che entra, al termine del duetto con Arrigo, nel palazzo davanti a cui ha avuto luogo la diretta solenne dei Funerali di Stato e in cui si troverà per la sua “In braccio alle dovizie”) e questa identità viene rafforzata dalla visione dell’esecuzione. Essendo il party parlamentare un party privato la notizia dell’attentato non è, evidentemente, nota alla stampa: Elena e Procida sono così prigionieri all’interno dello stesso palazzo governativo e stanno per essere giustiziati senza troppi clamori facendo poi, presumibilmente, scomparire i loro cadaveri. Monforte sovrintende all’esecuzione privata con freddezza e ci appare evidente che non deve essere la prima a cui assiste: per lui si tratta, in fondo, di un ennesimo regolamento di conti al di fuori delle regole della Giustizia. Quando Arrigo accetterà di chiamare “Padre” Monforte la scena, di colpo, diventa quella di una diretta televisiva, con Monforte che, magari a rete unificate, da alla nazione l’annuncio della riscoperta di suo figlio e delle sue imminenti nozze, salutate da un vacuo giubilo generale. Il violento e brusco passaggio che Verdi compie dal “privato” al “pubblico” in questo Finale IV (ovvero dall’imminente esecuzione alla festa popolare) viene reso con una forza pari solo al disagio che, da spettatori, sentiamo nell’evidente ambiguità morale che si è creata a questo punto dell’opera: il “buono”, Arrigo, si è piegato ai voleri del “cattivo”, Monforte (che però magari così cattivo non è), mentre Procida, presentatoci come patriota commosso, rivela un suo lato oscuro e spietato. Tutto questo non emerge dalla regia di Livermore, beninteso, ma dalla stessa opera verdiana: Livermore non fa che esternarlo con un linguaggio in grado di parlare al pubblico contemporaneo. Palese e significativo, in questo contesto, il disagio di Elena, da ribelle divenuta nuora del tiranno e come tale presentata alla folla osannante.
Il V Atto, ovviamente, è quello in cui si tirano le somme. Finalmente proviamo un imbarazzo vero, quasi fisico, nel vedere Elena e Arrigo amorosi e festanti, lui poi completamente calato nella parte del figlio del capo cui tutto è concesso. Il fatuo coro iniziale diventa il canto del pubblico di una delle tante trasmissioni trash della televisione attuale (Realissimo) e il problema della forma strofica nel Bolero di Elena è risolto brillantemente immaginando la prima parte come una prova della “reale” diretta televisiva del matrimonio, che poi avviene effettivamente durante “O piagge di Sicilia”. Il disagio che ci coglie nell’assistere a questa farsa, come all’ingresso di Arrigo assieme a due disinibite ballerine degli studios, è la perfetta traduzione di quell’ambiguità morale dei protagonisti che proprio in questo atto tocca il suo culmine. Chi era per la lotta, per la rivoluzione e non ha esitato a esortare i nemici alla violenza nella speranza di sollevare il popolo (Elena al II Atto) ora è parte integrante dello stesso sistema che avrebbe voluto sgretolare. Ci appare, allora, sgradevole anche Procida, che non aveva esitato ad aizzare gli ufficiali contro le spose siciliani e che ora non ha dubbi nel far coincidere l’inizio della rivolta con il segnale delle nozze, e ci appare ancora più sgradevole Elena, che da patriota pronta a morire per la sua terra ora rifiuta la rivolta e la libertà solo perché costerebbero la vita all’uomo amato. Il Finale, la rivolta vera e propria, è brevissimo e straniante nell’opera: sappiamo che la scena venne scorciata, durante le prove della prima all’Opéra di Parigi, tagliando l’atroce frase di Procida “Frappez-les tous! Que vous importe? François ou bien Siciliens, frappez toujours! Dieu choisira les siens! – Uccideteli! Che vi importa? Francesi o anche Siciliani, colpite tutti! Dio sceglierà i suoi!” col risultato che i Vespri del titolo sono un rapido coro di un minuto e mezzo che, sostanzialmente, lascia il Finale aperto. In questi Vespri torinesi la rivolta ci appare come una rivoluzione morale ed è forse la scena più pesantemente decontestualizzata in questa particolare visione registica. Livermore dice:
Oggi non ci può essere violenza. Oggi ci deve essere una cosa sola: riempire gli scranni del Parlamento con persone che hanno dignità. E allora si vedranno le persone, il coro, che si toglieranno la faccia di gomma e prenderanno posto in Parlamento, mentre su tutto il palcoscenico campeggerà la scritta che inneggia al primo articolo della Costituzione “Il popolo è sovrano nei limiti e nelle leggi della Costituzione”.
 Il popolo cessa quindi di essere una marionetta nei panni di chiunque voglia sfruttarlo per proprio tornaconto personale, che sia per ragioni sentimentali (Elena) o politiche (Procida o Monforte, che poche volte erano apparsi due facce di une medesima medaglia come avviene in questo spettacolo). Riprendendosi il potere il popolo cessa di essere una folla di gomma e ritorna protagonista dell’agone politico, schiacciando al proscenio le volontà e i giochi di potere dei singoli che lo dominavano e uscendo dal “fascismo mediatico” di pasoliniana memoria per ritrovare la propria dignità.
Il popolo cessa quindi di essere una marionetta nei panni di chiunque voglia sfruttarlo per proprio tornaconto personale, che sia per ragioni sentimentali (Elena) o politiche (Procida o Monforte, che poche volte erano apparsi due facce di une medesima medaglia come avviene in questo spettacolo). Riprendendosi il potere il popolo cessa di essere una folla di gomma e ritorna protagonista dell’agone politico, schiacciando al proscenio le volontà e i giochi di potere dei singoli che lo dominavano e uscendo dal “fascismo mediatico” di pasoliniana memoria per ritrovare la propria dignità.
Uno spettacolo molto emozionante, quindi, in grado di recuperare l’essenza di un teatro civile che non solo appare necessario nel momento storico in cui ci troviamo a vivere, ma che trovo anche straordinariamente pertinente con la sconsolata e antiretorica analisi storica compiuta da Verdi nei suoi Vespri Siciliani, sulla cui composizione probabilmente deve aver influito anche il sostanziale fallimento dei moti rivoluzionari del 1848 con il conseguente tramonto dell’ideale repubblicano.
Rispetto ai grandi maestri della regia contemporanea (penso a un Jones o a un Carsen) sembra mancare, a volte, quella cura capillare della recitazione che pure sarebbe essenziale, data l’ambientazione contemporanea, ma già così l’allestimento di Livermore si segnala come una delle più stimolanti e avvincenti riletture operistiche dei nostri tempi, in grado di dimostrare con i fatti quanto l’opera lirica possa essere attuale e quante cose abbia ancora da dire al nostro presente, senza essere né un museo né un semplice passatempo per borghesi annoiati.
Le citazioni di Davide Livermore sono tratte da Classic Voice Opera n. 53, marzo – aprile 2011; le foto sono state reperite nel sito ufficiale del Teatro Regio di Torino (Foto Ramella&Giannese).
Clicca sul banner per leggere tutti gli articoli della rubrica “Parliamo di Regia”:

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia License.